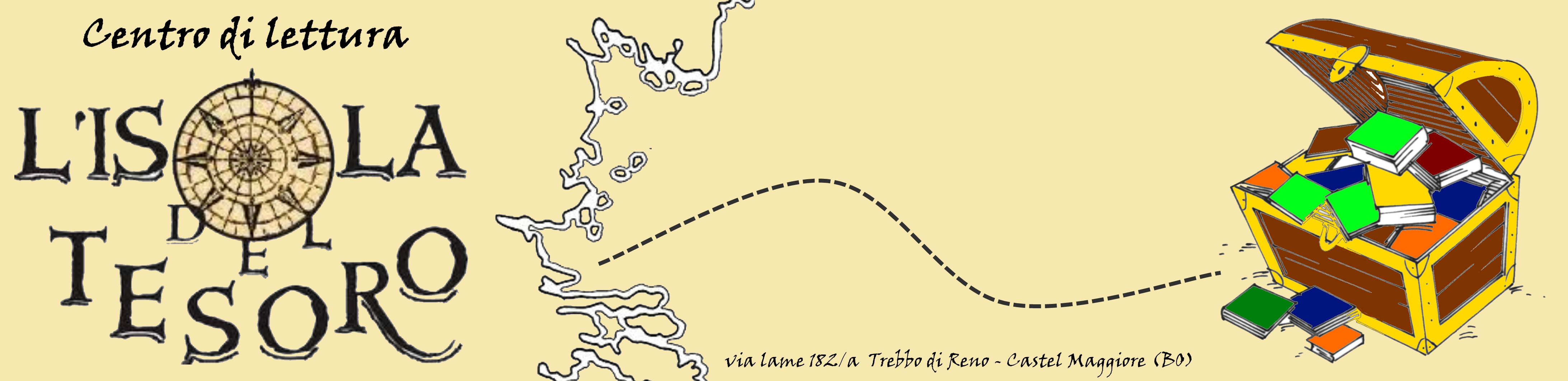L’Iliade cantata dalle dee, di Marilù Oliva (Solferino)
In questo terzo romanzo di rivisitazione dei poemi classici (dopo L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre e L’Eneide di Didone), l’autrice dà voce alle dee dell’Iliade che raccontano, dal loro punto di vista le vicende del poema. Ed il loro punto di vista è prima di tutto personale, nel senso che ciascuna parla anche di sé, aneddoti presi dall’Iliade ma anche da altri riferimenti della teogonia greca, che ci portano a conoscere l’animo profondo di queste divinità, catturate nel vortice di passioni umane e vincolate da un Fato che è più grande di loro. Un Fato che è prima di tutto Immortalità, uno stato invidiato dagli umani che non ne conoscono il peso psicologico immenso.
Le dee si alternano sulla scena come il coro tragico, sanno già cosa succede, ne partecipano emotivamente, spiegano antefatti, coinvolgono empaticamente il lettore. I sentimenti che le toccano sono vari, come per l’uomo: gelosie, rivalità, dispetto e invidia, ma anche autoconsapevolezza dei propri difetti, impegno per l’altro quando all’altro sono legate da un rapporto speciale, in particolare di maternità, come Teti per Achille o Afrodite per Enea. Gli dei di Marilù Oliva non sono remoti, inaccessibili, cristallizzati in un mito che appartiene all’antichità classica. Sono onnipresenti. Anche ora. Con tutto il portato delle loro personalità che nel tempo hanno solo acquistato sempre più aneddoti e storie per partecipare, come possibile, alle vicende degli uomini.
Forse, in fondo a tutto, c’è un sentimento di pietà, non pietas, ma compassione, nel suo significato greco di solidarietà nella sofferenza. Perché se sono immortali non sono distaccati dalle passioni che muovono gli uomini, le sentono e le condividono. E quanto più sono passioni devastanti, deliranti, distruttive come quelle che aleggiano sui protagonisti dell’Iliade, allora tanto più si sentono presi negli eventi e interagiscono come possono.
Protagonista assoluto, deus ex machina negativo perché interviene ad annientare e non salvare, è il Fato, quel destino scritto che può essere preconosciuto ma non contrastato. Cassandra, Ettore, Achille, Patroclo, Agamennone, Elena, ed tutti gli altri eroi che sembrano comparire sulla scena solo per intonare il loro canto del cigno, sono già condannati: non dalla nascita, però, ma da un loro preciso atto. Emerge una sfumatura moderna del Fato antico, in queste pagine, un’ombra di libero arbitrio: ciascuno di loro ha fatto qualcosa, in passato, che lo ha segnato. Immutabilmente. Ma forse all’origine una scelta era possibile? Cassandra poteva accettare l’amore del dio del Sole? Ettore poteva evitare di andare al duello con Achille? Patroclo avrebbe potuto rientrare dopo essersi solo fatto vedere? Agamennone avrebbe potuto lasciare Briseide ad Achille? O no? C’è un abisso di umanità in quelle loro scelte funeste, e ci sentiamo indotti a pensare che in realtà neppure quelle fossero davvero scelte disponibili.
Oltre al Fato, fra i protagonisti ‘astratti’, c’è il conflitto. L’istinto alla discordia che è innato nella natura umana e divina. Ma gli dei in qualche modo se ne districano, gli uomini vi si aggrovigliano continuamente fino a perdervisi. Anche perché qualcosa differenzia le due categorie: gli dei sono pochi, rappresentativi di una categoria, gli uomini sono tanti e la discordia che è bisticcio fra i divini, diventa guerra fra i mortali: “Che si sgozzino a vicenda, questi uomini!” esordisce Eris alla sua prima apparizione “Scarafaggi dell’immenso che è stato loro elargito, parassiti per ottusità. Io sono nata dalla loro incapacità di vivere in amabile intesa. Eppure basterebbe così poco per capirsi e fugare il rischio di ogni guerra: abbandonare le ambizioni smodate, comunicare, accordarsi. Tenersi per mano, tanto la fine di ciascuno è all’orizzonte”.
Eris tocca anche un altro tema ricorrente, quello della fugacità della vita e di tutto quello che muove i sentimenti, del traguardo unico che aspetta tutti: “Con cieca ostinazione continuano a ignorare l’unica certezza che li accompagna fin dal primo giorno, quello della loro caducità” (un’eco dei versi petrarcheschi Oh ciechi, e il tanto affaticar che giova? Tutti torniamo alla gran madre antica e il vostro nome a pena si ritrova ).
Qua e là come scintille di richiamo all’oggi, interpretazioni moderne di certi comportamenti: di fronte alla strage di troiani, pungolati da un’assurda ambizioni di gloria, l’autrice ammicca a prevaricazioni professionali: “Quando dilagano i favoritismi, i mediocri si gongolano nell’abbaglio che la loro vacuità sia scambiata per talento”. Ed Enea che “ha imparato quanto è amaro non essere considerati proprio da coloro che non cambieranno mai opinione sul nostro conto” come è attuale nel senso di frustrazione di chi non si sente visto sul lavoro, nelle relazioni familiari o amorose.
Bellissima la scelta di far aprire il romanzo non ad una dea, ma ad una figura delle più derelitte e meno ricordate, forse, dell’Iliade: Creusa, la moglie di Enea, che scompare nel momento della fuga: quando Enea lascia Troia, aprendo così la storia dell’Eneide, si carica in braccio il padre e prende per mano il figlio. La compagna, forse dà per scontato che resti al suo fianco. Ma non è così, lei incredibilmente scompare, si dissolve nel confine fra la storia che finisce e quella che inizia.. Ed è lei che chiede, in cambio del suo dissolversi nel nulla, che le dee si facciano portatrici di tutte le voci perdute.
Ad alternarsi sono Atena, Teti, Afrodite, Era, Eris; ma anche due mortali, toccate dal divino: Cassandra ed Elena. Fra le quali l’autrice immagina un’attrazione molto forte, quasi che fra di loro, donne neglette e respinte, si crei una comprensione ed una complicità reciprocamente salvifica.
La scrittura è sempre meravigliosa, un canto in prosa, voce vera di personaggi che la tradizione omerica ha consacrato con un testo inimitabile e imperituro e che sa ancora, riversato delicatamente in una scrittura di oggi, muove le corde dei nostri sentimenti e ci fa piangere con gli antichi eroi.