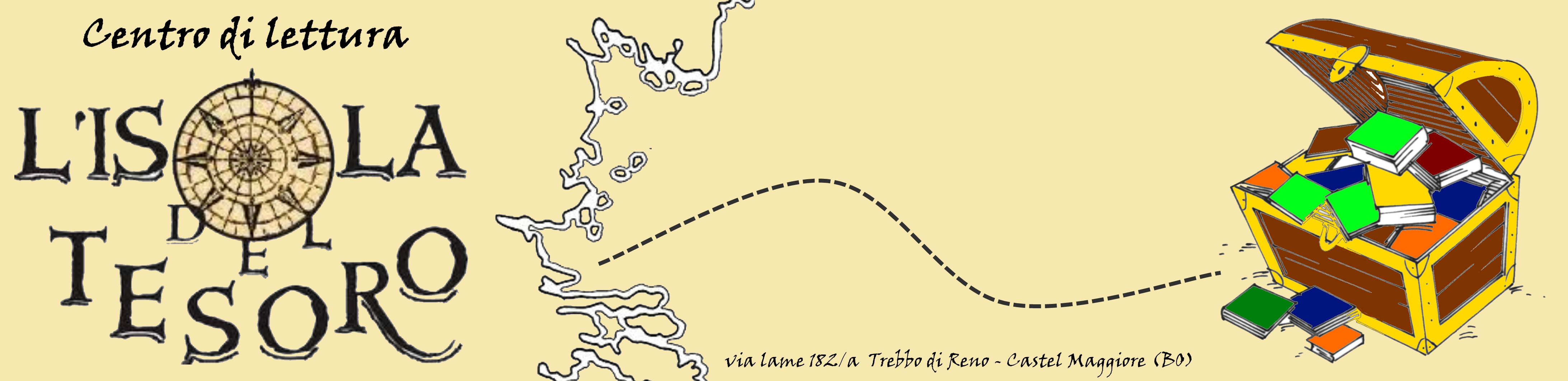Tutti giù per terra, di Massimo Fagnoni (Minerva)
Non si può giocare con la vita delle persone. Neppure quando portano addosso colpe già espiate o di cui si stanno pentendo.
Il nuovo romanzo della serie del maresciallo Greco, di Massimo Fagnoni, poliziotto e affermato scrittore di Bologna, comincia come un gioco, un videogame nel quale, grazie alle tecnologie sempre più sofisticate di oggi, la realtà virtuale si confonde con la realtà autentica. E su questo equivoco “gioca” l’intreccio, un equivoco strano perché chi vi cade sa benissimo che vi sta cadendo e vuole decisamente cadervi (si rifa al fenomeno della Second life che ebbe una vasta diffusione negli anni ’90).
Greco, a letto con una potente influenza e sinusite, costretto ad antibiotici ed antiepiretici, viene coinvolto ugualmente nell’indagine che parte dall’assassinio efferato di un giovane zingaro figlio di Jakup, uno dei capi dei gruppi rom dislocati a Bologna che anni prima aveva conosciuto Greco e con lui aveva fatto un patto di rispetto che non aveva più violato, dimostrando una dignità che tanti sedicenti perbenisti non possono vantare. L’assassinio così brutale non è giustificabile né per lui né per Greco. La casa del maresciallo diventa così dépendance del Nucleo Operativo. Accoglie quegli uomini che conosce bene, di cui sa di potersi fidare, di cui apprezza talenti e caratteri. Una delle caratteristiche dei romanzi di Greco, infatti, ancor più che in tanti altri romanzi seriali è la capacità del protagonista di farsi spesso da parte per dar risalto ad altre figure, alle loro competenze, al loro valore. Fagnoni rende così omaggio ad un’intera struttura, quella delle forze dell’ordine nelle quali non c’è necessariamente una “prima donna”, ma tanti grandi uomini, capaci di dare ciascuno, secondo le proprie facoltà, il proprio prezioso e determinante contributo. In questa storia un ruolo decisivo è svolto da Carmine, di una squadra dei Carabinieri di Roma dedicata ai crimini violenti. Greco lo chiama a Bologna per avere in aiuto da lui quegli strumenti di sensibilità e percezione psico-fisico-emozionale che lo caratterizzano e che ha affinato con l’addestramento speciale: “Quando c’è di mezzo la morte, quella determinata dalla mano dell’uomo, non c’è mai solo la scienza ad aiutarti (…). E la follia alla base della nostra brutalità può essere ricondotta a un certo innatismo animale. L’idea innata, sopravvissuta in noi, della prevaricazione di un individuo sull’altro per le solite questioni esterne: il controllo del territorio, il desiderio di possesso, l’odio razziale, eccetera”.
Ed è Carmine a convincere a collaborare con la giustizia sia Barbi, ex vigile, sia De Luigi, giornalista di cronaca che tutti nell’ambiente riconoscono dai libriccini neri sui quali prende sempre appunti. Fagnoni dedica toccanti parole a questa categoria che è a contatto, ogni giorno, con l’umanità più fragile ed emarginata: “Il suo mestiere maledetto è come una contrazione involontaria ormai, ogni volta che vede un’emergenza, sangue o intuisce dolore e disperazione, lì è il suo lavoro, il suo obiettivo, la fonte della notizia, la sua ragione di essere, perché un giornalista di cronaca non è nulla senza il dramma, il delitto, la sofferenza”.
Spesso thriller e gialli s’incentrano su di un serial killer, un pazzo spietato che uccide ritualmente più persone a distanza di luogo e tempo più o meno ravvicinata. Qui, non è il killer ad essere seriale, ma le vittime. E gli assassini sono un gruppo di pazzi dalla vita reale del tutto normale che si è fatto volutamente irretire nelle maglie di un piano criminale senza precedenti, ordito da un individuo di intelligenza pari alla spietatezza che forse – ma a questo dubbio non si avrà una risposta chiara neppure alla fine del romanzo – porta la cicatrice, ancora profonda ed evidente, di un’offesa subita tanto tempo prima. Perché all’origine del male c’è sempre o quasi sempre il male: “A volte accade che qualcuno sia costretto a pagare per i propri errori e per quelli degli altri. In questo buffo paese la giustizia segue percorsi strani, giri tortuosi fra garantismo e buonismo, fra approssimazione e vergogna, senza dignità, senza rispetto per le vittime, come se uno dopo essere stato violato, storpiato, umiliato, offeso, se non addirittura massacrato, dovesse essere cancellato, nascosto, dimenticato, come una memoria imbarazzante dei nostri peccati”. Un drammatico quesito amletico: quanto la giustizia istituzionalizzata è in grado di rimediare ai delitti? Quanto può far espiare, redimere il colpevole a fronte delle ferite profonde e mai del tutto rimarginate delle vittime?
Il fil rouge del piano criminoso esiste. E Greco e i suoi lo capiscono ben presto. È il senso di una giustizia propria, incondizionata, che sembra voler sanare i buchi della giustizia italiana e dell’espiazione individuale: “Tutta un’intera macchina da guerra si sta muovendo in città per compiere omicidi inutili, che apparentemente hanno come unico filo conduttore un soggettivo e discutibile desiderio di giustizia”.
Ma all’inizio e alla fine di tutto, quello che resta è l’amicizia. Un sentimento caro all’autore che vi ha dedicato il messaggio intrinseco di altri romanzi, come Nelle viscere di Bologna. L’amicizia ha ispirato con passione l’intero intreccio, a partire dall’attesa di Olmo e Aulo nella macchina, per la prima impresa criminosa insieme che sarà seguita da altre. Un’amicizia che non esiste ancora, è solo conoscenza, anzi, ancora più embrionale, rapporto collaborativo. E Olmo spiega l’origine del nome di battaglia che ha scelto, Butch. Butch dal film Butch Cassidy con Paul Newman e Robert Redford, la cui scena finale è rimasta nella memoria dell’autore per anni, decenni, e riaffiora periodicamente con la forza di un’emozione che sa rinnovarsi di continuo. E riesce a ricreare, nel finale, la stessa scena. Un’amicizia sincera, perché fondata sull’assoluto presente, senza bisogno di nient’altro. Nessun mattone dal passato e in fondo nessuna attesa dal futuro.