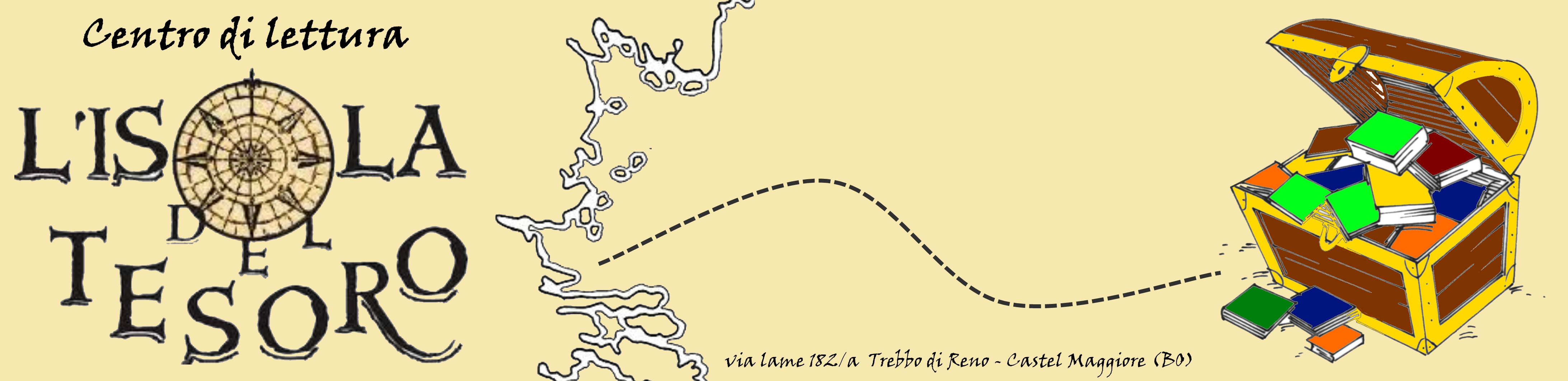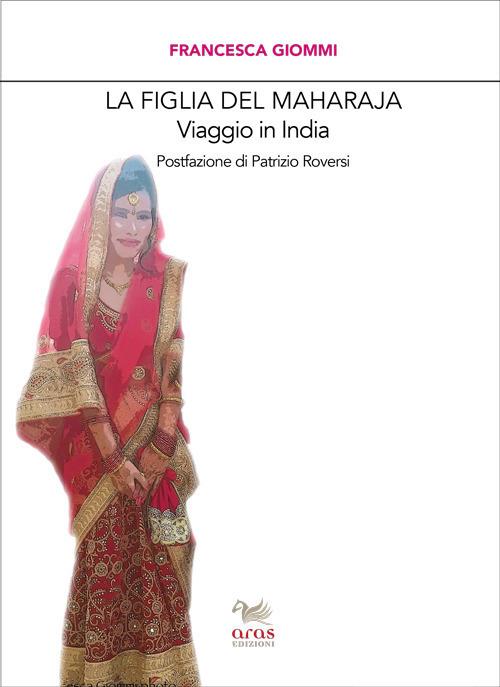
La figlia del Maharaja (Aras)
L’India nel diario di un’esperienza di viaggio vissuta come un volo di fantasia, un tuffo nelle atmosfere magiche di un luogo che è talmente ricco di contrasti da non poter essere colto, davvero, nella sua interezza.
L’autrice, Francesca Giommi, ben consapevole delle contraddizioni socio-economiche del Paese, ha scelto di seguire nel suo racconto il fil rouge dell’incanto, con l’intento di assimilare quella realtà, farla sua, in un abbraccio di affetto che ne celebra la bellezza piuttosto che la miseria.
La protagonista, Beatrice, è finita in un gruppo turistico organizzato, trascinata dall’esuberante forza di convincimento dell’amica Alessandra, la quale però, proprio all’ultimo, vi ha rinunciato per la sorpresa di sentirsi chiedere in moglie dal fidanzato di una vita che non avrebbe mai pensato che si decidesse a fare il grande passo. Con una telefonata euforica, pianta in asso Beatrice, la quale, avatar dell’autrice, non accetta di rinunciare come ha fatto l’amica. E va avanti da sola. Non se ne pentirà.
La ridente ironia con cui prende il via la storia rimarrà la cifra di tutto il romanzo in un affresco divertito dei vari componenti del gruppo, dell’insolita guida del tour, un indiano con i Ray-Ban, e stramba figura della “freccia umana”, l’addetto alla segnalazione ad altri mezzi o ai passanti dell’intenzione di svolta del pulmino, “sporgendo e agitando energicamente un braccio fuori dal finestrino”. Un’ironia delicata, sottile, rispettosa, che tiene avvinto il lettore, con il sorriso che lo fa sentire parte di quel gruppo. Ma non solo. Anche parte di un mondo così lontano dal suo per storia, cultura, tradizioni, ma che la sa accogliere in un abbraccio di luci, ombre, brezze olezzanti, suoni, silenzi: “Ciò che più l’attraeva in quegli stretti vicoli incorniciati da fantastiche architetture color ocra, era il vociare all’unisono di un’umanità così varia da provocarle smarrimento, ma al tempo stesso suscitare il senso di un profondo universale riconoscimento”.
È ciò che dà calore e umanità al racconto di viaggio e lo fa diventare romanzo. Dal fine humor dell’intreccio della storia, alla commossa, stupefatta, appassionata contemplazione delle bellezze di quel mondo.
Bellezze in senso lato, comprendendo non solo ciò che è oggettivamente bello come lo può essere Jaisalmer, la città fortificata interamente scolpita nell’arenaria gialla che le ha procurato il titolo di “città d’oro”. Ma anche ciò che è bello in senso simbolico, per quello che rappresenta e tramanda, come il tempio di Karni Mata, popolato da uomini-topi o come le mistiche figure dei sadhu che Bea e il suo gruppo incontrano nel Jehangir Mahal, edificio quasi vuoto, abbandonato, spettrale. I sadhu sono persone particolari, che vanno guardate da lontano, rispettosamente.
Francesca con Bea accompagna il lettore attraverso la regione del Rajahstan, dello Shekhawati, una sorta, quest’ultima, di museo a cielo aperto per le dimore seicentesche dei mercanti Marwari che, commerciando in pietre preziose, aveva potuto costruire sfarzose residenze. E noi con loro ci culliamo dolcemente sulle acque del lago Pichola, saliamo a dorso d’elefante la serpentina di gradini del Forte Amber, “per fortuna ombreggiati, rinfrescati da zampillanti fontane e allietati da venditori di ogni sorta di souvenir e mercanzia” rimaniamo profondamente toccati dalla storia dell’amore infelice e contrastato di Shah Jahan e Mumtaz Mahal, che si staglia agli occhi del mondo in una delle nuove meraviglie assolute, il Taji Mahal, all’interno del quale ci sembra quasi entrare passo passo rispettosamente con la protagonista.
In dialoghi strappati in incontri casuali con persone del luogo, Bea riporta sempre un senso di pace, di rilassamento che una cultura, se tollerata e integrata, può trasmettere come un tesoro prezioso: culti religiosi con i loro riti, i loro simboli, le usanze, come il ghoomar, il ballo comunitario con cui un tempo si venerava la dea Sarasvati e che oggi le donne del Rajahstan eseguono in occasioni di buon auspicio come matrimoni e festival; questi, in particolare, sono davvero numerosissimi in India ed uno degli aspetti folkloristici più curiosi per il turismo.
“Sono le questioni di tolleranza e multiculturalismo a costituire la sfida esistenziale dell’India all’alba del terzo millennio” perché soggetta per secoli a invasioni, incursioni, invasioni e dominazioni, ne ha sempre accettato le culture, “ruminandone le differenze e trovando sempre spazio per credenze e religiosi che potessero convivere con la fede originale vedica in un tollerante sincretismo”. Emblematico di questo sincretismo è la stessa divinità suprema indiscussa del pantheon induista, Shiva, che ha addirittura 1008 nomi diversi con cui essere invocato.
Il cibo ritorna più volte nel racconto del viaggio, soprattutto per la varietà infinita di sapori e odori che le più diverse spezie offrono. E con un po’ di pazienza e spirito di curiosità o semplice assuefazione, il gruppo ha cominciato ad apprezzare e distinguere alcune specialità. Solo di riso, apprendono dalla loro guida, ne esistono 86 varianti a seconda della zona di produzione.
Con Bea ci divertiamo anche per il senso di familiarità che si instaura nel gruppo e cresce parallelamente alla conoscenza che si fa sempre più approfondita fino anche alla costruzione di nuovi legami. E alla fine del viaggio, ci sarà qualcosa di molto profondo che li legherà per sempre, anche quando saranno ritornati ciascuno alla propria vita: “Lo stesso stupore e trasporto, la stessa gratitudine e leggerezza sospesa da cui si sentiva pervadere l’animo”.
“L’uomo dice che il tempo passa; il tempo dice che l’uomo passa” recita un antico detto. E l’ultima immagine del romanzo, sulle rive del Gange che scorre imperturbabile, si radunano sadhu e vedove bianche, paria e brahmini, turisti e pellegrini, fedeli e peccatori, sofferenti e penitenti, col loro carico di umanità e mortalità, di bisogni e desideri in una lotta quotidiana per appagarli o liberarsene”.