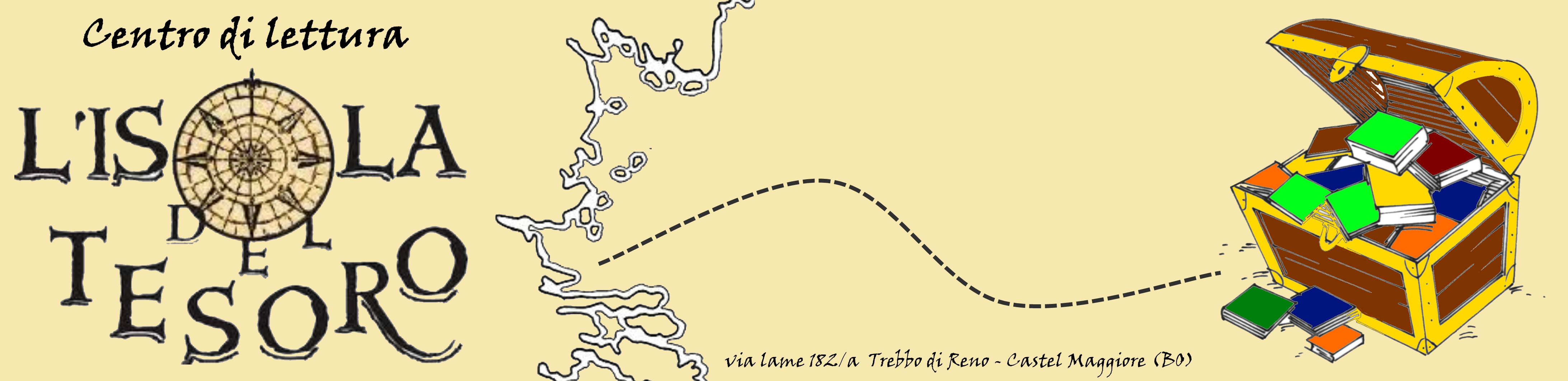Sale di pietra, di Maria Federica Baroncini (Pendragon)
La guerra. La seconda guerra mondiale, in una prospettiva diversa: non quella di chi la fa e neppure quella di chi la subisce. La guerra di chi la fugge. Per volere, per dovere, per sé, per gli altri, per i figli, per i genitori.
Donne sole alle quali la guerra ha tolto l’uomo che avevano accanto o che avrebbero potuto avere accanto. E che hanno dovuto rivoluzionare il proprio modo di vivere, ma anche quello di pensare, di agire nelle relazioni.
Mafalda è la protagonista faentina, “introversa, poco socievole, ma mai soggiogata”. Giovane moglie e madre, aveva conosciuto la Grande Guerra da bambina, e aveva sperato di non vederla mai più. Alle prime avvisaglie del nuovo conflitto, con un solo sguardo angosciato esterna al padre tutta la propria paura di perdere il marito. E succede. Antonio parte per la Russia con un’amarezza rabbiosa nel cuore, con la sensazione che non sarebbe ritornato, perché andare a combattere in un paese così immenso è una pura follia. E non tornerà.
Sola, Mafalda deve rimboccarsi le maniche per crescere e salvare i figli e la madre. Sono una famiglia fragile, confusa, spaventata, ossessionata da quegli allarmi di bombardamento imminente nei quali è ridotta e concentrata tutta la guerra. Per loro la guerra è lì, in quelle fughe nei rifugi, nel buio dell’attesa, della speranza che il botto sia sufficientente lontano perché possano aprire ancora gli occhi. Per loro la guerra è nella condivisione soffocante e umiliante di spazi stretti, nella paura tangibile, negli odori, nei sospiri, nei pianti sommessi. Per loro la guerra è nell’abbandono di quel poco di cui era fatta la loro vita, nel quale si riconoscevano e si sentivano a proprio agio.
Lasciare la casa dove avevano sempre vissuto, dove sapevano come gestire la propria, come accogliere le persone, cosa offrire, è uno strappo violento: “Da quando erano rimaste vedove entrambe, per la Lina ogni decisione si scontrava con la paura di venire ingannate”. L’autrice dipinge in modo autentico, lo stato d’animo di chi deve, per la prima volta nella vita, chiedere senza poter dar nulla in cambio. E questo significa “che si è davvero toccato il fondo. Che la dignità umana non può tollerare oltre. Che il limite è colmo e che, una volta superato, rimane spazio solo per varie forme di disperazione: ‘Per grattare via il sale. Se mai c’è. Ci fanno mangiare i sassi. I sassi li chiamano sale. Sale di pietra’”.
E’ un’emozione che non si trova spesso nei romanzi di guerra e che l’autrice ha saputo elevare a nucleo centraledella propria trama: il senso di invadenza, di inutilità, timidi e continui ‘grazie’ uno dietro l’altro. Pronunciati per e con imbarazzo, vergogna, umiliazione. Poi Mafalda si rende conto che quell’atteggiamento di ritrosìa era ben più irrispettoso e fuori luogo della disponibilità a ricevere senza poter dare nulla in cambio: “Al nostro posto voi avreste fatto uguale” dice Minghì. E lei capisce non solo l’importanza di accettare un aiuto sincero ma anche il valore di quella loro presenza apparentemente passiva: il calore di affetti nuovi e spontanei che rappresenta il prezzo più congruo per l’ospitalità ricevuta.
Ma la guerra non dà loro tregua, li perseguita anche lì. Sembra seguirle, stanarle. Dopo aver devastato con centinaia di incursioni aeree la città di Faenza, si sposta nelle sue campagne: la linea gotica si avvicina. Un’altra fuga, attraverso le campagne rese paludi dalle piogge, nel fango che avviluppa, insudicia, infreddolisce. E di nuovo la città. Ma non la loro casa. Lì non possono ancora tornare. Il rifugio, questa volta, è rappresentato dalle cantine di Palazzo Milzetti.
Poco oltre la metà del libro, il focus della trama si sposta su altri protagonisti: l’Avvocato, consorte della proprietaria di Palazzo Milzetti e la sorella Ersilia che la guerra ha colpito, come Mafalda, con l’arma diretta e indiretta dei bombardamenti. Diretta perché i bombardamenti costituiscono minaccia concretamente fatale, indiretta se quella minaccia resta disattesa. Ma non è così. Il romanzo della Baroncini pone proprio l’accento su questo aspetto. Sulle ferite psicologiche non meno distruttive, a volte, di quelle fisiche. Anche Ersilia è fuggita dalle bombe, ma non come Mafalda, nelle campagne, nei rifugi. È fuggita con la mente, con la parola. Lo choc l’ha resa muta e inerte, dimentica del mondo intorno a lei, bisognosa di cure quotidiane, di essere vestita, nutrita, accompagnata.
In viaggio, come ogni anno, da Milano verso la Riviera Ligure, l’Avvocato la conduce nel palazzo di Faenza, dove chiede al fedele custode Giuseppe di trovare una persona fidata per accudirla. Ed il custode pensa subito a Mafalda. Con un taglio completamente nuovo, la Baroncini accompagna le due protagoniste in un recupero di coraggio e fiducia attraverso il viaggio nel passato, nella storia, nella mitologia.
La storia è bellissima, nuova, fresca pur nella sua drammaticità, il linguaggio fluente, anche per gli incisi dialettali che riportano le brevi frasi delle persone che non hanno studiato.
Le pagine dedicate agli affreschi del palazzo sono stupende, perfettamente calate nella storia con delicata armonia. Il palazzo diventa un protagonista, un gigante buono che accoglie nel proprio antro per proteggere, e che schiude nuovi orizzonti con i colori e le luci delle proprie stanze più leggiadre. È un omaggio singolare ed efficace ad un bene artistico di Faenza che ne divulga l’importanza culturale e storica.