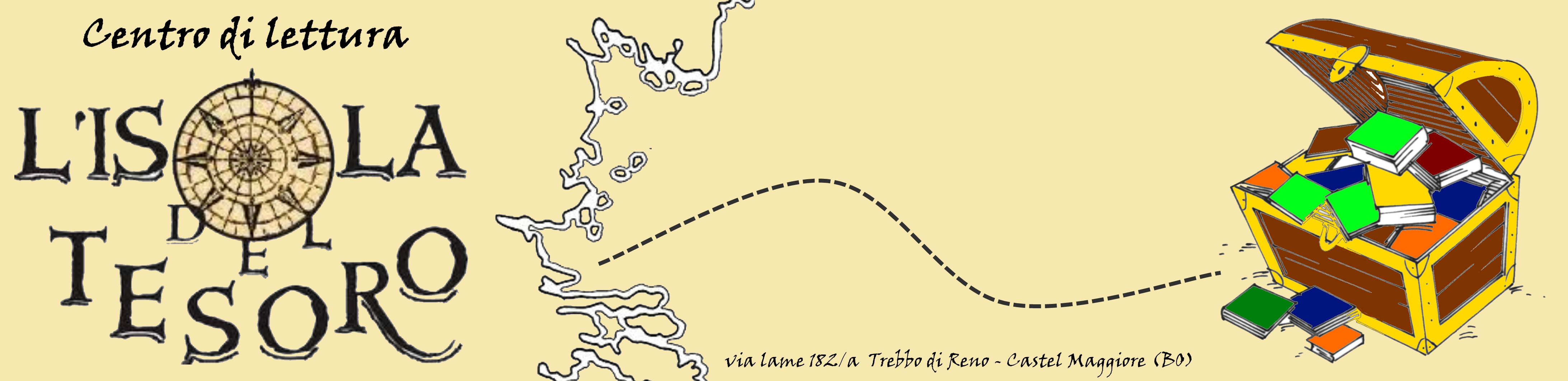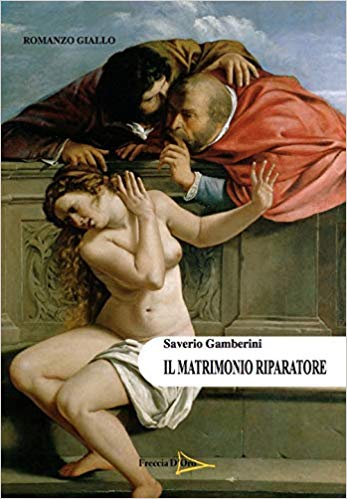
Il matrimonio riparatore, di Saverio Gamberini
Dopo quattro romanzi ambientati nel Polesine di oggi, Gamberini ha voluto risalire alle origini storico-sociali di quell’ambiente che gli è così caro. Ne è emerso un romanzo storico nel quale il delitto – anzi, i delitti, nella fattispecie, la violenza perpetrata nei confronti di una donna oltre al contrabbando di armi – non sono il semplice fulcro di un intreccio giallo, ma sono espressione concreta di una realtà quotidiana. Non c’è un criminale da scoprire, c’è un sistema sociale da capire e, soprattutto, da cambiare.
La trama del romanzo, nel senso letterario del termine, si svolge lungo le linee di varie storie, quella del giovane soldato dell’esercito austro-ungarico che, ferito e depredato delle armi, viene soccorso dalla gente del paese, quella del contingente militare che si trova ad affrontare una terribile epidemia di malaria, quella di Egidio e delle sue scorribande per rubare e contrabbandare le armi dei soldati, ma soprattutto quella di Brunilde, violentata (come tante) dal fattore, che l’autore segue nel complesso del dramma personale e dei molteplici risvolti sociali. Sì, perché era un fenomeno purtroppo generalizzato, quello di uomini che approfittavano della loro posizione, dell’intoccabilità di cui godevano nel contesto locale e della soggezione che le giovani sentivano nei loro confronti.
Brunilde è il simbolo di una generazione femminile per la quale si cominciava appena a percepire il tremendo impatto psico-emozionale di una violenza. La vergogna, l’umiliazione, l’affronto superavano l’individualità della persona per colplire la famiglia ed il paese, tanto che nell’immaginario collettivo di quel tempo, indotto anche da una legislazione che ammetteva il delitto d’onore, le giovani erano portate a sentirsi colpevoli. Brunilde attraversa così questo terribile evento, passando per tutte le fasi che la cultura di allora reputava necessarie: l’allontanamento dalla famiglia e dalla casa, la meditazione sulla propria colpa in un convento, la prospettiva di poter scegliere solo fra il velo da monaca e il matrimonio riparatore che l’avrebbe legata per la vita all’essere più ripugnante che per lei esistesse. Seguendo Brunilde nel suo percorso, dal punto di vista medico-psichico, si apprende l’importanza dell’elaborazione del trauma, del ricordo che veicola il suo superamento: “Per quanto assurdo e disumano fosse gettare l’onere della colpa sulla ragazza violentata, la fase di riflessione nascondeva un vantaggio: le permetteva di elaborare il trauma e le evitava il pericolo della rimozione. Rimuovere le fasi più traumatiche della violenza subita, cercando di pensare ad altro, avrebbe significato confinarle in un angolo remoto e dimenticato della mente, da dove non se ne sarebbero mai andate, ma avrebber continuato a condizionare in modo inconscio la vita ed i sentimenti della ragazza. Quel ricordo, se ignorato, sarebbe diventato un disturbo perenne senza identità, un’oppressione indefinita(…) La meditazione sull’accaduto, anche se caricata di sensi di colpa, avrebbe messo chairamente in luce tutte le fasi della violenza subita e la persona avrebbe sempre avuto chiaro in mente il nesso di causa-effetto”.
Ma oltre a quello di Brunilde, il lettore vive anche altri percorsi, perché se lei deve aspettare che sia il destino a volgere le cose a suo favore, Telemaco, il giovane che ne era innamorato, deve aggirare la mentalità nella quale era cresciuto, ignorare la presunzione comune di vergogna e colpa della vittima, scrutarle l’anima nel profondo per vedere, dietro la paura, l’angoscia e la disperazione, il fremito innocente che la caratterizzava prima della violenza subita, è un passo difficile e sofferto, con il quale deve rigettare “l’influsso di quel potere occulto che per tanti secoli condizionò il pensiero della gente. Quel potere che riversava sulla donna l’onere della purezza assoluta e allo stesso tempo ne attribuiva all’occorrenza l’origine del male. Quel potere occulto che era solito colpire chi già soffriva, aggiungendo al suo dolore l’onere della colpa” .
Di traverso a questa ricca e affascinante trama, l’autore colloca un altrettanto ricco e affascinante ordito fatto del variegato paesaggio storico-sociale della prima metà dell’800: le malattie, il lavoro delle mondine, estenuante, pericoloso per la contaminazione di malattie dai parassiti delle piante marciscenti, la minaccia della malaria, i primi medicinali naturali, le abitazioni che erano poco più che stalle se non stalle stesse, che offrivano calore per la presenza degli animali, le cose d’uso quotidiano, le candele di stearine che sostituirono quelle di grasso, le riunioni politiche, la carboneria moderata dei grandi latifondisti che nell’ideologia celavano spesso il proprio interesse (“il concetto di libertà coincideva con la libertà di sfruttare a piacere i contadini ed i braccianti riducendoli alla fame. I diritti umani coincidevano con i loro privilegi”); e ancora le diverse visioni dell’istruzione femminile che l’Austria voleva imporre e nelle quali era osteggiata dalla Chiesa, la considerazione che l’Italia, che si tentava da decenni di liberare e unificare, era un concetto spesso molto vago al quale la classe più umile e numerosa era per lo più estranea: “Nessuno di loro aveva la minima idea di cosa fosse l’Italia”. Avevano sì, un concetto di omogeneità che li portava a sentire come artefatto la divisione, ma era un concetto naturale creato dalla loro quotidinità: “la gente oltre il fiume era la stessa gente della sponda veneta. Il fiume, che pareva dividere due mondi diversi, in realtà era un luogo di condivisione e di scambio, era il contesto comune dal quale nascevano e crescevano le stesse usanze, gli stessi stili di vita e le stesse capanne di canne e fango”. Questa era l’unità che la gente del Polesine comprendeva, non l’entità politica delle cui dimensioni e natura non avevano alcuna coscienza.