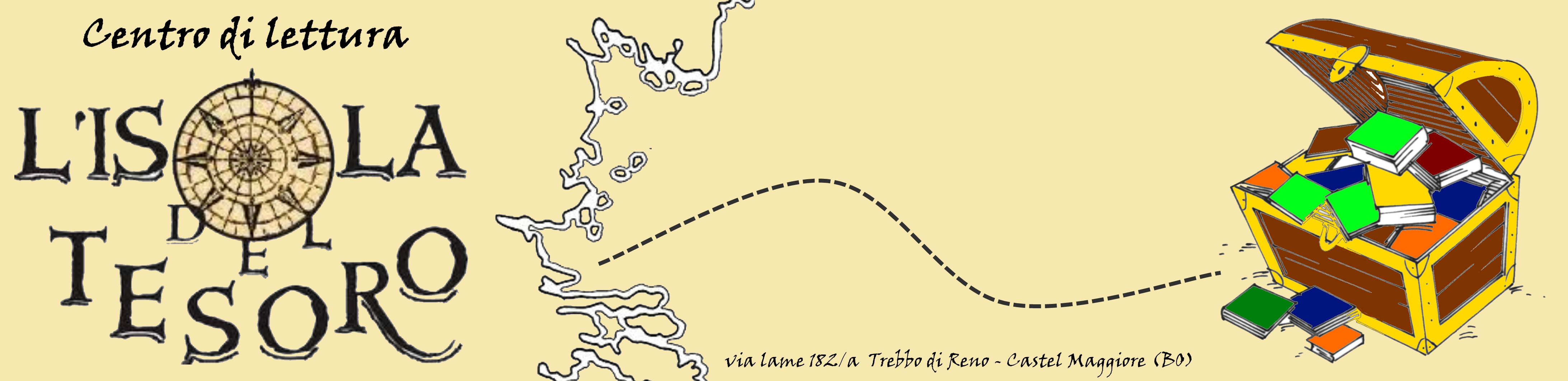La paura nell’anima, di Valerio Varesi (Frassinelli)
È l’Appennino lo sfondo suggestivo di questo romanzo nel quale, al tema del tempo impietoso che sottopone a selezione naturale i piccoli borghi, l’autore affianca quello della paura, non la paura del singolo ma quella di un’intera comunità. Come altre volte, anche in questo caso attinge alla realtà di oggi, ad un evento che ha colpito l’immaginario collettivo, per tessere una trama che affonda nell’intimità di un piccolo paese, Montepiano, portando alla luce l’intricata rete di rapporti personali ed economici. Un paese che fino a quel momento era sopravvissuto nonostante l’imperversante industrializzazione che attira normalmente le nuove generazioni verso la città, gli studi universitari e una carriera aziendale, e che si trova improvvisamente attaccato da una forza naturale sì ma intangibile, ben più oscura delle forze naturali alle quali sono abituati da secoli e che hanno imparato come dominare: “Sono convinta chela paura peggiore sia quella di cui non capiamo l’origine. Quindi non riusciamo mai ad allontanarci. Saltiamo come pulci qua e là avendola sempre addosso persistente e angosciante”. E invece di far fronte comune contro di essa come erano abituati a fare da sempre, fanno esattamente quello che li porta alla rovina: si dividono. Quei rapporti economico-sociali che avevano tenuto in vita il paese fino a quel momento, nei quali tutti si riconoscevano perchè costituivano l’equilibrio che consentiva loro di sostentarsi, ora vengono spezzati, denunciati, vendicati. E la spavalda affermazione del maresciallo espressa nelle prime pagine: “Sono sicuro che quando la gente ha paura, il mondo funziona meglio. Se c’è la paura c’è anche rispetto” rivelerà ben presto, sciaguratamente, la sua infondatezza.
In paese, dove Soneri si trova insieme ad Angela per una breve vacanza in fuga dal calore della città, si verifica uno strano incidente: uno del posto viene trovato ferito da un colpo d’arma da fuoco e in forte stato di choc. Un incidente che la gente immediatamente collega al criminale latitante, trasformista e inafferrabile di cui parlano da un po’ i mass media, il sedicente russo ex militare dell’Armata Rossa, Vuikovic, – che poi si scoprirà essere molto pù semplicemente un evaso serbo, “un criminale che rompeva la consuetudine, togliendo di mano ai poliziotti la carta della prevedibilità. Al contrario, battendo traiettorie inedite, lanciava loro implicitamente una sfida”. Il mutismo di Brunetti, il suo sconclusionato parlare con citazioni in lingua straniera incomprensibili, cominciano a cucire un legame con l’assassino misterioso.
Quando poi Maurizio, un giovane isolato, inconcludente e dalle abitudini notturne e irregolari, viene trovato morto, non c’è più possibilità di ignorare il sospetto. Anzi, il sospetto si allarga subliminalmente estendosi a tutto ciò che esula da quello che è ritenuto normale per il paese, perché consolidato da quelle leggi che il tempo e l’ambiente hanno scritto.
I Carabinieri invadono il paese, cominciando un pattugliamento serrato continuamente alla ricorsa di qualcuno che è sempre intravisto, ma mai raggiunto. Qualcuno lo vede o crede di vederlo e l’Arma deve lanciarsi sul posto battendo le colline fino a quando una nuova voce lo segnala da qualche altra parte. Un gioco beffardo che non si capisce se sia giocato veramente dal criminale o dalle stesse vittime di una paura che ha trovato, casualmente e finalmente, uno sfogo ad una pressione che si andava accumulando da tempo.
Comincia così una collaborazione onesta e sincera fra polizia e carabinieri, che raramente come in questo romanzo appaiono vicini più di quanto l’opinione pubblica spesso li rappresenti: vicini e accomunati dall’estenuante svolgimento di un compito che spesso deve lottare contro un nemico più articolato del singolo criminale. In questo caso, è un’intera comunità a rivelare un codice comportamentale esondante i confini della legittimità: il bracconaggio, la caccia praticata con qualsiasi tipo di mezzo, è infatti per loro la risorsa più remuerativa. Una rete di squadre aveva creato una vera e propria organizzazione sottobanco che riforniva i commercianti di carni pregiate anche quando e come la legge non lo permetteva. Era la loro legge, quella che non era stata scritta dagli uomini ma dalla storia. E l’intruso che come un perno conficcato in questo sistema ne comincia a perforare la superificie consolidata, lo crepa e lascia spazio alla paura fino a quel momento tenuta a bada da equilibri consolidati: “Improvvisamente, la vita a Montepiano aveva preso un’accelerata strappando dalla consuetudine esistenze costruite sull’infinita ripetizione degli stessi gesti”.
Il personaggio più bello del romanzo, più commovente è Tilò, un mulattiere alcolizzato, isolato, che la vita ha portato a fidarsi unicamente della sua mula, alla quale ha dato un nome di donna, Teresa, e che rappresenta il simbolo della fedeltà, dell’abnegazione, della tacita accettazione. È una tacita accettazione quella che anche Tilò esprime nei confronti del paese. Non si integra, non si pone in contrasto. Convive su uno spazio condiviso senza disturbare quegli equilibri ma senza farne parte: “In paese hanno tutti qualcosa da nascondere: le tasse, la caccia di frodo, certi lavoretti edilizi, i vizi. Nessuno calpesta i piedi agli altri, ma con l’arrivo di quello è venuta a mancare la fiducia nel silenzio del tuo vicino. Il ricatto reciproco non è più riuscito a tener ferma la gente, il sospetto del tradimento si è diffuso”.
E la bomba della paura, con la sua esplosione, travolge anche lui. Suggestiva la visione ‘nemica’ perfino del regno animale: non solo quello, effettivamente minaccioso perché predatore, dei lupi, ma anche quello, apparentemente innocuo e perfino identificato spesso come piacevole, dei grilli. Gli uni incutono terrore perché echeggianti la lotta primordiale per la sopravvivenza; i secondi innervosiscono perché il loro canto continuo esprime l’indifferenza alla paura, sembra sottovalutarla o deriderla: “Quell’unica nota di solfeggio che accompagna i tormenti degli insonni, ricordando loro come un palpito diffuso il mondo là fuori e gli incubi che aspettano ingigantiti dalla notte. È il battito cardiaco che sale dalla terra a interrompere la quiete, con il suono striduolo della lima da ferro. Non c’è niente di pacificante nel canto dei grilli, nella sua insistenza monotono di rosario”.
Il mito del Baffardello che il vecchio sindaco ottantenne richiama continuamente e che neppure la vecchia maestra nega, è l’emblema di quella paura, la personificazione di una minaccia fremente che non possiamo dominare proprio perché irrazionale: “Anche quelli che non ci credono devono riconoscere la sua presenza. Negheranno, sicuro. Ma non potranno negare quel che succede, né liberarsi dalla paura”.
Tutto il romanzo reca l’impronta inconfondibile della prosa poetica e vagamente malinconica di Varesi, disseminata di piccole perle di similitudini, analogie e metafore: “La giornata estiva era entrata in quell’ora luminosa come l’adolescenza, quando non è più mattina e nemmeno mezzogiorno”; “L’ombra delle montagne schiacciava il buio nel fondovalle”; “…cercando di puntellare la frana dell’umore”; “Le frasi affogavano in quel lago di mistero che inghiottiva ogni spiegazione”.