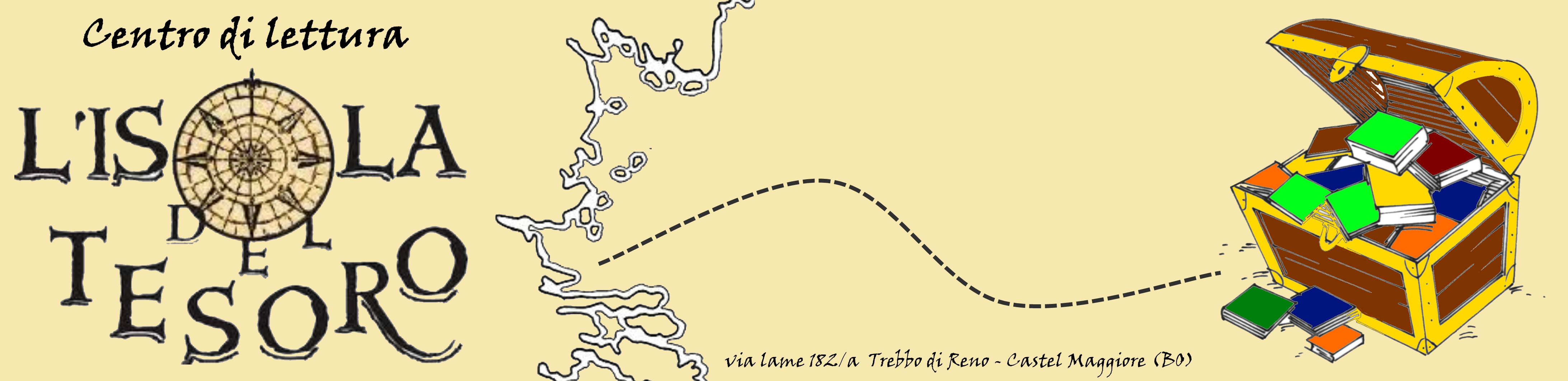L’Amazzonia interiore, di Luciano Caminati (Polaris)
Luciano Caminati, nato a Reggio Emilia vive a Bologna. Appassionato di viaggi e fotografia, ha esplorato territori primordiali, fra i quali, l’Amazzonia, del quale in questo breve e intenso romanzo, restituisce un’immagine intima, amara, sofferente. Il viaggio fu compiuto nel 1986 e al ritorno l’autore pubblicò immediatamente il suo reportage. Dopo oltre quarant’anni, la casa editrice Polaris ne ha pubblicato una seconda edizione, perché quelle impressioni provate allora, valgono ancora oggi. Quell’idea dolorosa, di un mondo che sta implodendo nella propria selvaggia solitudine perché incapace di comprendere la civiltà moderna, e tanto meno di adeguarvisi, ha marcato profondamente l’autore. E questa seconda edizione è un’eco di quel suo primo grido che allora volle lanciare al mondo con il suo reportage: un richiamo alla prudenza, al rispetto, alla riflessione sul valore di un mondo che è stato spesso frainteso e sottovalutato. Quella gente non è ostile e non è neppure chiusa. È saggia. Di una saggezza istintiva profondamente reale. Non c’è, per il Caminati di oggi, come il Caminati di allora scoprì sconvolgendosene, una possibilità di integrazione fra le due culture. Non c’è perché da un lato l’Occidente è inesorabile nel portare avanti il proprio imperioso bisogno di arricchirsi ed evolversi. Dall’altro, loro, i primitivi, sono consapevoli di essere più deboli e di non avere scampo.
Il protagonista, io narrante in prima persona, ha intrapreso quel viaggio dopo aver visto una fotografia che rappresentava un affluente del Rio delle Amazzoni: “quello spazio immenso, senza limiti, mi aveva esaltato”. Atterrato a Lima, è deciso a compiere la sua agognata spedizione fluviale: un fiume qualsiasi sarebbe andato bene, purché assomigliasse a quello della foto. Arriva così a Puerto Esperanza, un vilaggio di contadini e manovali bianchi e meticci. Tuttavia, sulle prime non riesce a trovare una guida. Finalmente ottiene da Pedrito, uno degli abitanti più isolati la promessa che suo fratello Domìnguez lo avrebbe accompagnato. Una promessa pronunciata come un oracolo: “Se il destino avesse la parola avrebbe parlato così”. E da quel momento, tutto sembra snaturarsi di prevedibilità e chiarezza. La stessa figura di Dominguez è misteriosa, sfuggente; al villaggio circolano strane voci, di un assassinio, e intorno al narratore si leva un’aura di inquietudine. È quasi commovente la sua incapacità di farsi scoraggiare. Ostinato e imperterrito, ha deciso di esplorare quel fiume e non si lascia intimorire da presagi che, alla sua lucida coscienza di uomo civilizzato, sembrano chiacchiere popolari. Alla fine Dominguez lo accetta sulla barca, senza parlare. Quell’uomo è la voce del mondo che l’autore ha voluto penetrare. E gli sta dimostrando che, se vuole farlo, deve accettarne le regole irrazionali. Così il viaggio inizia. Un viaggio che è già meta per il solo fatto di essere cominciato: “Il fiume mi accoglie così, aprendo le sue dolci braccia misteriose in un respiro che è brezza tipeida sul viso, tra i capelli. Un senso di pace infinita penetra i sensi, si infonde nell’animo, annega pensieri e turbamenti nell’oblìo di acque cupe e ammalianti (…) Il fiume non si perde mai. Mena la propria esistenza sempore nella stessa direzione, segue un richiamo remoto, senza fretta. Fluisce imperturbabile, amato, odiato, ignoto”. Lo sguardo impregnato di ogni immagine, suono, fruscìo, profumo, l’autore percepisce quel mondo come un unico immane essere vivente e visibile, nelle personificazioni della natura che, dopo la tempesta, “sembra leccarsi le ferite della propria ira” o delle radici contorte che, come “dita nodose e sensibili, palpano la rena, si insinuano in umidi recessi, solidamente avvinghiano un lembo di terra” o del vento che “sbuffa irrequieto come cercando la preda. Batte alla porta, scuote per un attimo le esili pareti di shapaja, infine fugge via sollevando un po’ di polvere e la mia ansia”.
La prosa di Caminati è intrisa di una vena poetica cangiante come il fiume, languida, profonda, impetuosa, struggente.
Durante una pausa dalla navigazione, oppresso da quel silenzio che la sua guida non sembra voler rompere in alcuno modo, il protagonista, quasi con rabbia e disperazione, cerca di spiegargli cosa lo ha spinto lì, come a giustificare il suo desiderio di invadere un mondo che non vuole – gli è sempre più evidente – essere occupato: “So che la mia strada passa di qua, alle origini del tutto e del nulla. Come un’intuizione che nasce dall’informe materia e ha bisogno di plasmarsi per essere se stessa”. Alla fine, apparentemente convinto, Dominguez lo indirizza al villaggio dei Cashinawa. E lo abbandona. Potenti le pagine che descrivono la sua determinazione a vincere lo sconforto e la paura, a puntellarsi su quella passione per un luogo dal quale si era sentito intensamente chiamato, a ignorare fantasmi che era lui stesso a crearsi e ad affrontare quella che sarebbe stata una prova di fede: la “ragione contro uno stato d’animo sempre più forte. E quanto maggiori erano le difficoltà tanto più grande era la resistenza a quella lotta intestina, quasi un’ostinazione che rasentava il rancore, l’odio per quella forza di massa inerte che si apriva e si chiudeva, che ammaliava e respingeva nell’inedia. Nessuna possibilità di fuga, crescenti rimpianti, un senso di impotenza incontenibile”.
È il momento, forse, in cui quasi d’un colpo, il protagonista elabora la propria esperienza: non un’avventura capricciosa ma una prova di vita, di conoscenza e accettazione. Il viaggio, dopo essere stato sopra il fiume e attraverso la giungla diventa interiore, un percorso di maturazione e cambiamento. Un’amara disperazione, rabbiosa, rancorosa, esprimono le sue parole, con l’aggravante di sapere che comunque non c’è nulla da fare per frenare la decadenza di questo popolo che sembra stia spegnendosi: “Gli stregoni non avevano più il potere di una volta, non si ricordavano nemmeno più le formule dei riti, i loro canti erano diventati patetici lamenti nell’inutile sforzo di dominare forze che non conoscevano più. Dove la ragione e la scienza potevano fare ancora poco o nulla, dove la magia e la superstizione avevano perso il loro dominio, questa era la terra di nessuno e lo spirito di Luis, come quello di tutti gli altri, vagava senza meta per un mondo improvvisamente ignoto”.
Così, quando lascia quei luoghi, il narratore porta con sé dubbi e incomprensioni che, si rende conto, hanno paradossalmente in sé molta più coscienza e razionalità di ogni acritica certezza di possedere la parte migliore.