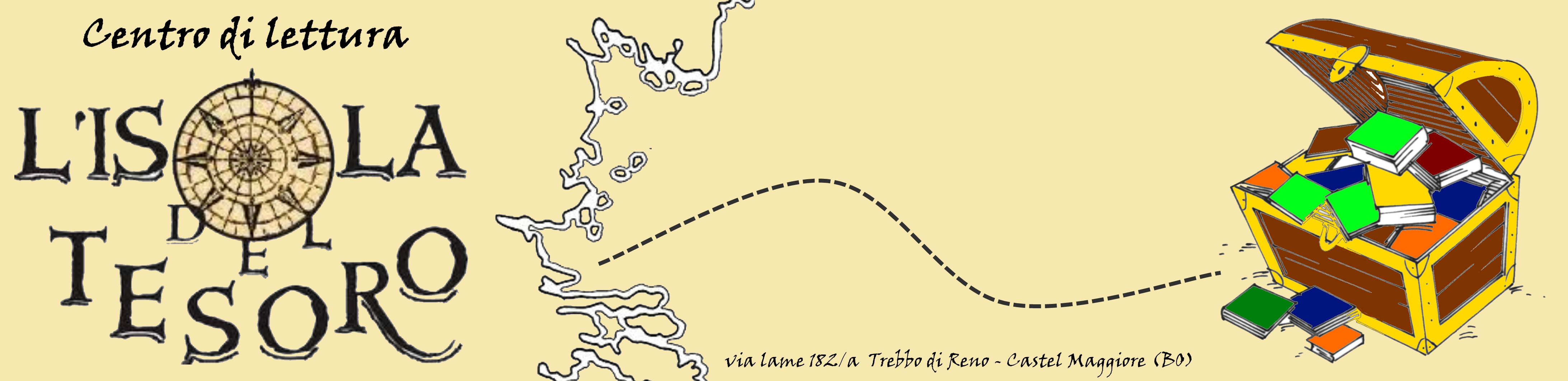Valerio Varesi, Lo stato di ebbrezza (Frassinelli)
In questo terzo capitolo della storia della nostra Repubblica, Varesi dà prova di una potenzialità stilistica sorprendente: la sua prosa si veste di slang in omaggio alla maniera spregiudicatamente vivida di Céline che l’autore ammira particolarmente come ‘fotografo’ realista: “La lingua si colorava così di un gergo più icastico. Smollavano del tutto le frontiere del buongusto in una completa ibridazione con la suburra. È la forma del linguaggio televisiva tipico degli anni ’80-’90, periodo nel quale è ambientato il romanzo, che adotta come registro linguistico per questo romanzo.
All’origine di questa scelta c’è la volontà di sottolineare il cambiamento sociale profondo, intimo dell’ultimo mezzo secolo. In un’intervista al Festival Trebbo Sui Generis 2020, Varesi ha richiamato l’idea di Marx secondo cui “la storia si ripete due volte, prima come tragedia, poi come farsa“: dopo la tragedia della guerra con la Resistenza e le rovine del dopoguerra, negli anni ’80 comincia la farsa: “La politica non conta più niente, è solo manovra, aggiusta i cambiamenti che l’economia produce: è ancella, mentre prima li governava“. Se a questa constatazione si aggiunge il risultato della somma di due frasi emblematiche, una della Thatcher, “Non esiste la società, esistono gli individui” e l’altra, di Reagan, “Lo stato non è la soluzione ma è il problema (…)”, questa idea meno stato più mercato diventa il comandamento di tutto il mondo economico” e lo scenario di questo terzo romanzo, nel quale si muove il protagonista, Domenico Nanni.
Dopo aver cominciato come giornalista dell’Avvenire, disgustato dalla decadenza dei valori nei quali aveva creduto, anzi, forse proprio in reazione ad essa, si riforma proprio come espressione di questa nuova faccia della realtà socio-politica: diventa uomo-immagine, responsabile marketing, con la funzione di creare qualcosa di artefatto e artificioso, falso, inventato per assecondare non più l’interesse pubblico, sociale, ma quello privato, di singoli individui.
Diversamente da lui, Tugnoli, ex compagno, resta la personificazione del sogno infranto, del comunista che all’improvviso, da parte di un tutto in fermento, si ritrova solo e non capisce dove siano finiti tutti gli altri. In più dialoghi i due si confrontano ma mentre il primo rimane disperatamente fermo agli ideali perduti, il protagonista compie un percorso formativo a ritroso, abbandonandoli.
È un percorso comunque sofferto, che passa attraverso la vergogna per questa prostituzione di sé rispetto a quello che era stato il suo credo politico in una giovinezza passata a raccogliere i detriti della Guerra e a sognare, come la generazione prima di lui, se non una vera rivoluzione sociale, per lo meno una graduale affermazione di principi di uguaglianza e condivisione dei beni dopo quella dell’impegno personale nella ricostruzione.
Ma poi, tra il cinico e l’affranto, realizza che “il mondo disumanizzato impone che ci si dimetta dall’essere uomini”: impressionato dalla sicurezza di Calcaterra, capo di un’agenzia pubblicitaria milanese, e fortemente condizionato dalla personalità di Susanna, la sua compagna, forse più disperata di lui all’inizio, ma più realista, meno sentimentale, forte abbastanza da riscuotersi con spregiudicatezza, accetta il gioco dei due, l’adeguamento a quel sistema completamente inetto e dissoluto: “Una volta che ti riesce di esserci dentro, al potere, ne assumi le sembianze. È lui che cambia te, mica il contrario”.
I due richiamano la coppia de Il rivoluzionario: anche nel secondo libro della Trilogia, è lui, Oscar, ad essere più rigido nelle proprie idee, impiegando anni per smussare quegli spigoli, mentre Italina fin da subito capisce come sia necessario ammorbidirsi e lasciare che le cose cambino un po’ per restare in fondo sempre le stesse. Qui, è ancora lui, Domenico a faticare a condividere la disincantata prospettiva di Susanna (“Non mi ero abituato a quella rarefazione di pensiero, mi sentivo ancora troppo orfano del dubbio”), ma comprende a poco a poco che è l’unica strada ormai percorribile: “È successo qualcosa là fuori, e la gente che ti camminava a fianco improvvisamente torna indietro. Non capisci cos’è questo stato, ma non riesci ad andare avanti, sei travolto e allora indietreggi anche tu: non puoi far altro. Prendi solo atto che non potrai mai farcela”.
Così si pone di fronte alla nuova realtà, come di fronte ad un televisore che trasmette immagini che non lo coinvolgono, che lo stupiscono sulle prime, lasciandolo poi indifferente e svuotato. Dal bianco e nero degli anni della guerra, al seppiato della ricostruzione sofferta ma fiduciosa, agli slavati colori della Dolce Vita fino a quelli pacchianamente smaglianti degli anni ’80 e ’90.
Uno stato di ebbrezza generale, l’illusione di aver raggiunto, con il benessere, un traguardo che in realtà nessuno sa cosa sia, perché non esiste, non è concreto. È superficie linda sotto la quale non c’è nulla: “la totale rimozione della storia, la fuga in mondi artificiali per non vederne lo schifo”. E allora, trionfa quella classe politica, rappresentata da Craxi, dotata della giusta dose di cinismo per farsi carico di questa “gigantesca opera di rimozione del passato, di autoassoluzione con formula piena di un intero Paese”
Lo specchio in cui si riflette è sua madre, l’unica che riesce a mantenersi ferma di fronte al grande cambiamento generale, l’unica coerente con ciò che era stato, con i valori di un tempo. E lui in quel riflesso vede fronteggiarsi “due visioni del mondo che non s’incontravano più”.
Il romanzo è un lungo pannello di affreschi impietosi di un Italia priva di ossatura ideologica ed etica. E l’autore è il Varesi di sempre, dalla prosa impeccabile nella quale ogni parola ha l’aggettivo perfetto e, costante, fluida, intuitiva, poetica, la metafora più eterogenea sfuma ogni periodo tanto che la lettura, anche nel gergo triviale céliniano scelto per questo romanzo, resta tipicamente carezzevole.