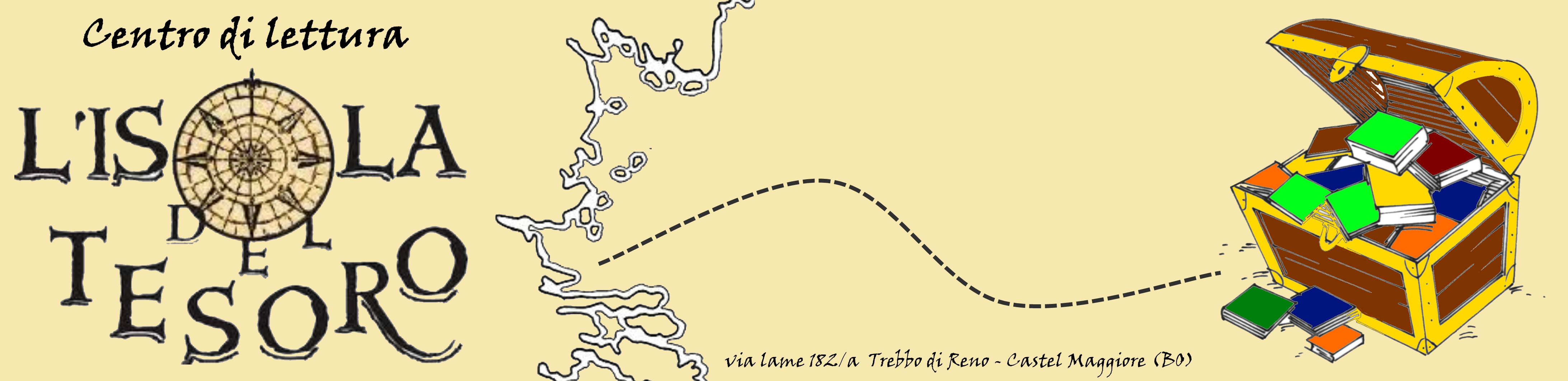E io c’ero…, di Maria Giovanna Bruzzi (Edda)
L’autrice, bolognese (di Anzola), laureata in lingue con la passione per il mondo dell’infanzia, al quale ha dedicato tutta la sua vita professionale – prima come educatrice di scuola materna poi come Counsellor nell’associazione ludico-creativa da lei fondata – ha scritto questo racconto come riflessione personale, nei mesi della prima gravidanza. Una gravidanza inizialmente a rischio che ha fin da subito portato avanti con passione e amore infinito, dando voce e identità alla creatura che sentiva crescere dentro di lei, spostando l’attenzione da sè a lei.
Il racconto è un monologo del feto che, dopo le prime parole con cui si riconosce “arrivato” da qualche parte: (“All’improvviso mi trovai catapultato con forza in un ambiente strano, sconosciuto, che però alla prima impressione risultò confortevole”), comincia il suo percorso di presa di coscienza di sè, dei propri confini fisici, del luogo e della materia di cui è circondato, delle prime percezioni sensoriali.
Ogni capitolo è dedicato ad un preciso sentimento che supponiamo che un feto sia in grado di percepire: confort, paura, identità, preoccupazione, dubbi, felicità, curiosità. La scoperta della propria identità passa dalla coscienza di essere semplicemente al riconoscimento di una qualità che è cambiata dal maschile al femminile, o meglio dall’essere una O all’essere una A per come sentiva di essere apostrofata dalle voci esterne. Molto, infatti, del mondo fuori dal suo, le arriva da rumori, movimenti, suoni, colpetti, e soprattutto emozioni ricevute dal corpo che la ospita, una persona, “la mia persona” come la chiamerà per tutto il periodo, che ha sentimenti come i suoi, che le trasmette una sintonia profonda e irrinunciabile. Dopo di lei, “la voce” più bassa e carezzevole, che le parla così spesso, dal fianco della sua persona. Sono due riferimenti del mondo esterno al quale si attacca con passione e totale dipendenza. Sono quelli che, ritrovati alla nascita, dopo il trauma delle contrazioni e del parto, la tranquillizzeranno finalmente, dandole il coraggio e il calore per accettare quella nuova condizione che inizialmente le faceva paura: il freddo, i rumori, la luce, sono stati uno choc: l’improvviso venir meno del filtro del corpo materno è reso nel racconto con una drammaticità infantile di squisita naturalezza e con la stessa dolce naturalezza è resa la placida rassicurazione offerta dal seno materno, dall’abbraccio della madre e dalla voce del padre, quella voce “profonda e rassicurante che avevo sentito molto più spesso delle altre e che, a differenza di queste, si rivolgeva direttamente a me, chiedendomi come stavo e giocando come quando ancora ero là dentro (…). Quando lui mi teneva fra le sue braccia forti mi sentivo tranquilla; c’era una particolare armonia tra me, lui e la mia persona che trasmetteva una sensazione di pace. Loro si volevano bene e si prendevano cura di me”.
Più intimi e legati ad una percezione metafisica dell’essere sono i due riferimenti al preconcepimento: l’autrice parla di un luogo in cui le anime pre-esistono, con un intento ben preciso: distinguere il mancato arrivo casuale di un bimbo indipendente da qualsiasi volontà, che non annulla la forza intrinseca della vita e lascia intatta quindi una o più possibilità di realizzarsi, da quello che invece è un esplicito rifiuto dei genitori che toglie all’essere in potenza qualsiasi speranza di giungere ad esistenza.
In tutto il racconto emerge una grande partecipazione dell’autrice, un sentimento curato in sé per nove mesi e affidato ad un diario che è venuto alla luce della pubblicazione più di vent’anni dopo, con le delicate illustrazioni della figlia che ne era stata protagonista: ancora autentico e spontaneo come quando è stato scritto.