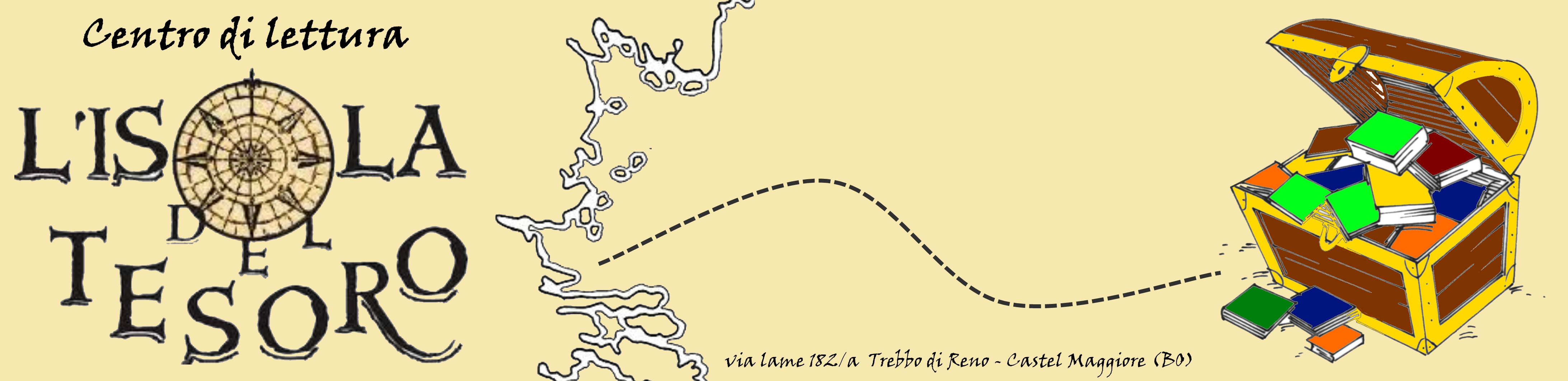Ho trovato un cuore a terra e non era il mio, di Claudia Venuti (Sperling & Kupfer)
Si sente un’eco de “La coscienza di Zeno” in questo romanzo di Claudia Venuti, scrittrice riminese approdata al successo con la sua trilogia d’esordio “Passi di Mia”, per l’approfondimento introspettivo quasi maniacale della protagonista. Nina rielabora il disagio giovanile nel quale era sfociata la sua infanzia per la delusione di una famiglia nella quale non ha potuto o saputo trovare il proprio spazio, il riconoscimento di sè, il supporto per attraversare l’adolescenza serenamente. Il padre, continuamente assente per lavoro, pronto a donare solo beni materiali, grazie ai propri guadagni, convinto che lei non avesse bisogno d’altro che di quello che si poteva acquistare col denaro, la madre innamorata perdutamente di lui, capace di accettare i suoi viaggi e perfino, quando lo si scoprirà, il suo tradimento, sono stati per Nina anelli di una catena di sentimenti negativi che l’hanno riempita di disordine, senza lasciare alcuna breccia da cui far entrare la speranza e la fiducia: “Provai a mettere tutto in ordine, ma capii di essere destinata al disordine, al chiasso dei pensieri, alle discussioni con me stessa, ai compromessi con i miei limiti, agli sguardi severi allo specchio, alle litigate con il mio orgoglio, alla lotta con i miei silenzi e quella con i miei casini interiori”.
Disprezzo, rabbia, amarezza, sono stati i sentimenti dei quali Nina si è nutrita, isolandosi senza distinzione di sesso, di età, di contesto, da qualunque esemplare del genere umano. Chiusa in se stessa, si macera capitolo dopo capitolo in quel velenoso sentimento di torto subito che non lascia altre aperture, non permette una elaborazione costruttiva perchè si alimenta solo di fragilità e frustrazione: “Dentro di me ero come un iceberg emi andava bene che si vedesse solo la punta del mio mondo, tutto quello che c’era nei miei abissi doveva rimanere lì perché portare qualcuno a fare un giro da quelle parti era una concessione che non avrei saputo gestire, era un viaggio troppo pericoloso, azzardato, e che, a dire il vero, non avevo mai fatto neanche io. Forse ero scesa giusto di qualche metro in profondità in quello spazio che puoi vedere anche a occhio nudo quando sei in piedi su una roccia a picco sul mare nelle giornate di sole, ma non ero mai andata oltre e non immaginavo assolutamente che lo avrebbe mai potuto fare qualcun altro. Non senza il mio permesso, non tenendomi la mano”.
Nel panorama di statue di sale che agli occhi di Nina sono le persone del suo mondo, una sola si distingue, per il calore che la anima e che riesce a raggiungerla: Bea, sua compagna di squadra a pallavolo. L’unica che non si fa spaventare da quella sua fredda scontrosità, dal suo viso sempre serio, dalle poche, caustiche parole che accetta più con dispetto che con piacere di scambiare con le altre. E’ Bea che, paziente e comprensiva, le si affianca in quel percorso di muto smaltimento del veleno di rabbia che Nina si porta dentro. Sa che l’amica è molto di più di quella maschera acida, di quel torvo distacco, sa che soffre intimamente e che è sola. E le resta accanto con la capacità, grazie alla propria vitalità e spensieratezza, di accettare i suoi momenti bui, i suoi silenzi, e di sostenere e incoraggiare le brecce che cominciano a schiudersi nella sua corazza.
La seconda parte del romanzo si svolge nei mesi di chiusura 2020; paradossalmente, è in quel momento che Nina, a poco a poco, esce davvero dal buio dell’astio covato per anni: “Subire era una cosa facile, essere passivi lo era ancora di più e quella quarantena sembrava perfetta per chi navigava nell’inconsapevolezza perenne, per chi non si fermava mai a fare bilanci, a capire dove e come migliorare, privo di una dote che lo spronasse, un motore che magari aveva sempre avuto dentro ma che non aveva mai avuto il coraggio di accendere per vedere dove lo avrebbe condotto”. Prima in chat, poi al telefono, poi con videochiamate, passaggi emblematici di un approccio cauto al recupero di un contatto con l’esterno, ma soprattutto con l’altro, Nina si avvia verso il processo di rielaborazione del disagio cronicizzato in lei. Una rielaborazione finalmente catartica, che la porta a sciogliere il ghiaccio del proprio cuore che tanti anni prima aveva immaginato di rinchiudere in una teca di vetro, una teca che, a poco a poco, s’incrina, poi s’infrange. Ed il cuore di Nina si fa sentire, fertilizzato dall’accettazione degli errori altrui e dalla dolcezza di un perdono richiesto e concesso. Il cammino di liberazione per Nina non potrà però mai essere completo e definitivo se non passando attraverso il rapporto col padre. Un rapporto che, fin dall’infanzia, è decisivo per una figlia, e sulla cui mancanza, lei aveva costruito la fortezza del proprio rifiuto sociale e della propria inadeguatezza. Ma la figura paterna, detestata con furore, non è mai crollata, coltivando per anni con l’attesa e l’espiazione, la propria speranza di ridare vita ad un rapporto con la figlia che sentiva vitale per entrambi.
Non è facile tenere alto il livello narrativo-espressivo in un romanzo fondamentalmente introspettivo ma l’autrice ci riesce. In questo riecheggia la lucida, meticolosa autoanalisi di Zeno. Non ci sono eventi eclatanti, colpi di scena nel senso tradizionale del termine. Ma la trama riesce ad appassionare e tenere avvinto il lettore con la potenza di quell’introspezione che la protagonista (e l’autrice dietro di lei) fa su se stessa con la collaborazione di poche, preziosissime figure della sua vita che sono state capaci di starle a fianco senza invaderla, senza spaventarla, ferirla.