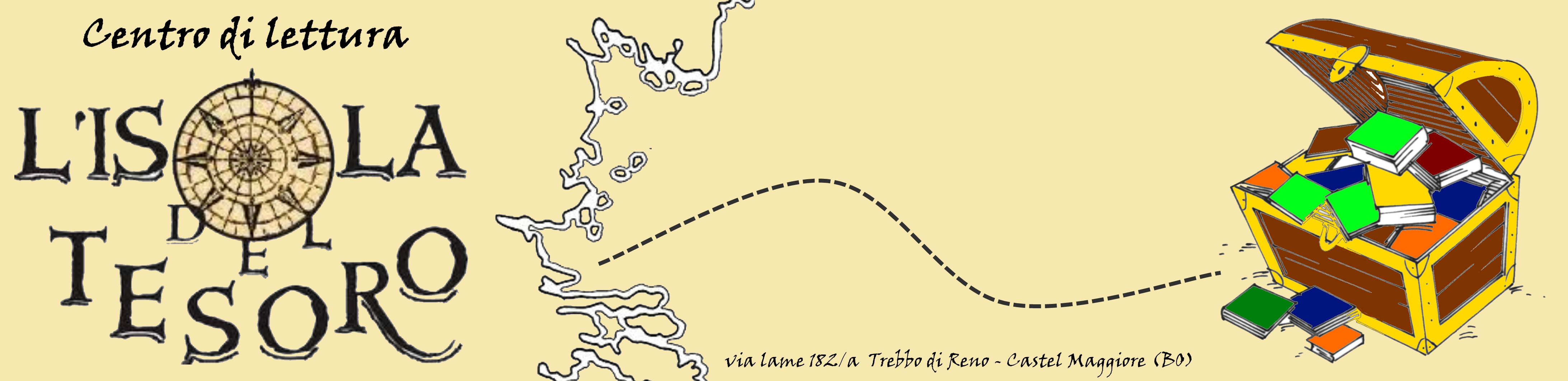Il maragià di Firenze, di Paolo Ciampi
Un romanzo in facere che si costruisce pagina dopo pagina, come una vita che si forma giorno dopo giorno. Ispirato dalla statua All’Indiano presente nel giardino detto “Le Cascine” alla periferia di Firenze, Paolo Ciampi, fiorentino appassionato di storie, di viaggi, di storie di viaggi e di viaggi “di carta”, espressione che usa riferendosi ad Emilio Salgari e al suo straordinario mezzo di trasporto alternativo – libri, giornali, documenti – tesse una storia fresca, nuova, commossa e commovente. Incuriosito dal personaggio orientale a lui sconosciuto, con garbo e sensibilità comincia a guardarlo in modo nuovo: non più, semplicemente, come un simulacro di pietra, ma come l’uomo che quel simulacro rappresentava: “I raggi sorprendono il busto alle spalle. Lasciano in ombra i lineamenti, ma sanno di carezza prima del sonno. Quindi mi raggiungono e così provano a cucire due destini. Il mio e quello dell’uomo che ora è enigma di pietra. Per tutti, l’Indiano”. Quella luce, quel silenzio, gli aprono nuovi orizzonti e si accinge a tessere il filo con il quale ha già deciso di scrivere la storia quel personaggio.
Avvia così le sue ricerche su Internet, giorno dopo giorno, dalla primavera alla fine dell’estate, finché la stagione è mite e può raggiungere quel luogo in bici; perché la ricerca documentale la fa a casa sul computer, ma quella più intima, sull’uomo, la fa lì, nel parco, interrogando la statua, cercando addirittura di abbozzare con lei un dialogo. Sa benissimo che oggettivamente il dialogo è impossibile ma proprio atteggiandosi ad indispettito per l’ostinato tacere della statua, può scherzare con se stesso, con la propria razionalità: “L’indiano sarà pure quella statua in fondo a Firenze, quello sguardo che non mi guarda, quell’espressione che non si concede. Però è anche una mano che non si stacca dopo che ci si è presentati”.
L’indagine documentale si rivela altrettanto ardua di quella personale, soprattutto all’inizio e alla fine. Perché quell’uomo ritratto in un parco fiorentino è un principe indiano, di un piccolo regno, Kolhapur. Poche righe su La Nazione del 1870 per ricordare che il tal giorno il principe S.A.R. il Rajah di Kolapore moriva nella Locanda della Pace dove aveva preso alloggio: “Queste e poche altre parole, prima della pietra. Prima di un monumento per una persona che a Firenze arriva e muore”. A poco a poco, però, quelle poche righe si moltiplicano grazie ad una scoperta davvero inaspettata: il diario del maragià. Un diario breve, superficiale, certo, ma schietto, autentico; il diario che un ragazzo di vent’anni, in viaggio per l’Europa per la prima volta, compie con il suo seguito, senza immaginare che non sarebbe mai più tornato in patria.
L’autore è intenerito da questa storia, dalla giovinezza del principe, dalla fugacità della sua apertura al mondo, e nel cercare di trattenerlo in una sorta di limbo letterario sospeso tra il passato, immutabile, ed il presente, ancora malleabile istante per istante, recupera tutte le informazioni possibili su di lui. Ogni dato rinvenuto dall’autore su quel personaggio così poco noto è il frutto prezioso di un numero enorme di documenti indagati, come un elisir distillato da un’immensa quantità di erbe: “Tracce di vita che galleggiano sulla grande Rete. Indizi in letargo nei fondi delle biblioteche (…) Relitti che tornano a galla dopo il naufragio della nave, poche cose nel mare che si è placato”. È come se, apprendendo il più possibile lui stesso della cultura indiana, restituisse a Rajaran quello che il giovane non ha potuto apprendere della cultura europea. Come se potesse compensarlo della perdita di stupore che la morte precoce gli ha imposto. E non è solo lui a compensarlo, almeno in minima parte, di tutto ciò che con la morte ha perduto. Lo fa anche la città di Firenze, nella persona del sindaco, Ubaldino Peruzzi, “uno di quei moderati che un tempo in Toscana crescevano come i campanili. Moderati sì, però, capaci di scompigliare le carte e di portarsi un pezzo di strada avanti rispetto ai puri e ai duri”. A quel giovane che non tornerà mai più, vivo, nella sua terra, non ha voluto negare almeno quel viaggio verso un’altra terra ignota, alla quale, per la cultura indiana, si può approdare solo arrivando dalle acque di un fiume, cenere di una pira abbandonata alla corrente. Così, dopo intima riflessione, “decide a prescindere da moralisti e ben pensanti, consentendo che a Firenze si faccia ciò che non si è fatto mai: un funerale induista in terra cristiana, l’Arno come il Gange” e i Fiorentini, quella notte, hanno sfidato il gelo e il sonno per salutare il giovane principe.
Così la storia che non si sa se davvero diventerà una storia, ma che lo è già proprio nell’umiltà della sua forma e nel realismo del mistero che ne costituisce l’intreccio, finisce per contenerne tante altre, non solo del maragià, ma anche dell’autore, dei suoi interessi, del suo modo di vivere la propria città, di ciò che cerca nelle sue letture: “Una città sembra solo una città e invece dentro racchiude continenti. Penso che questo possa valere anche per la vita delle persone, che sembra una e invece sono una moltitudine”.
Ne scaturisce così il racconto di un’insolita amicizia che forma un romanzo vero molto particolare, apportatore di nuove suggestioni. È un viaggio, insieme al maragià nella cultura della sua India, ma è anche un viaggio con lui nell’Europa e nell’Italia di quegli anni. Perché, sì, c’è tanta India, ma c’è anche tanta Italia in questo intreccio di due persone che si guardano da due mondi diversi, lontani, irraggiungibili l’uno per l’altro (come la scoperta che sono proprio di quel 1870, i primi chioschi per la vendita dei giornali, le edicole). È un viaggio che è piacevole fare insieme a Paolo Ciampi, per la sua sensibilità, il suo interesse per la conoscenza, la sua disponibilità all’ascolto, all’incontro, all’entrata in mondi nuovi. Ed anche per la sua toccante prosa: lirica e ricchissima di metafore, analogie, anafore. Certi paragrafi si leggono come versi sciolti di una poesia perfetta, nella quale la musicalità è data non dalla rima o della metrica, ma dalla luminosità delle immagini evocate.