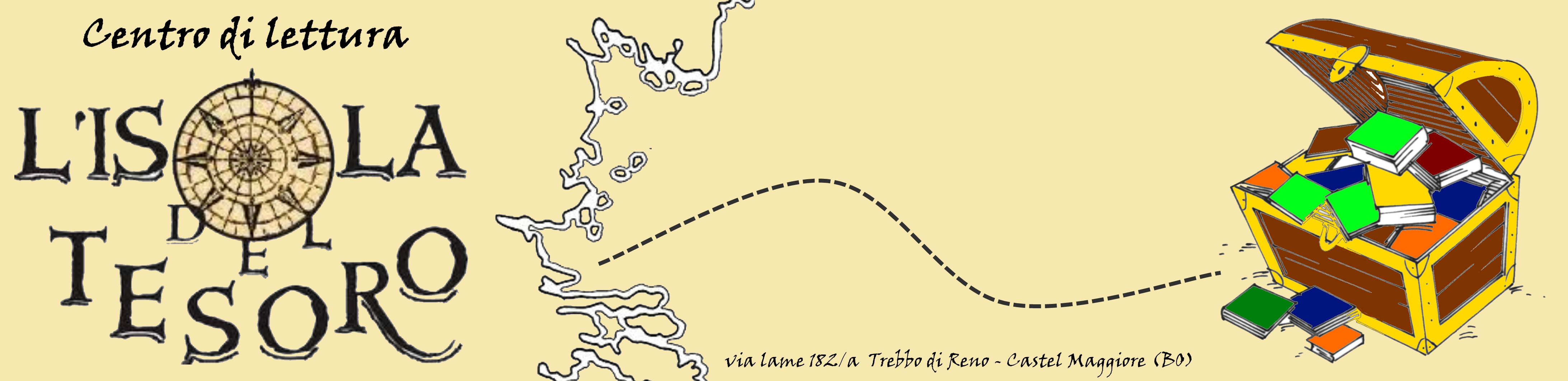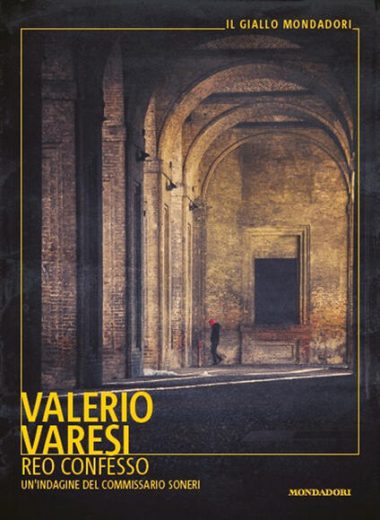
Reo confesso, di Valerio Varesi (Mondadori)
“Solo lasciandosi avviluppare dalla noia è possibile sperimentare il sussulto vitale dello stupore”.
Gli incipit di Valerio Varesi sono qualcosa di spettacolare, sempre. Ogni suo romanzo si apre come un sipario sullo sfondo dell’attacco orchestrale dell’ouverture. Un annuncio. Una preparazione. Una richiesta di attenzione e ascolto. E proprio l’attesa, come indugio e senso di sospensione è la cifra di lettura di questo suo nuovo romanzo. Un grande romanzo, sulla scia dei precedenti e, questa volta, anche sulla scia di un altro precedente, La promessa di Friedrich Dürrenmatt, un Requiem per il romanzo giallo, come lo sottotitolò l’autore austriaco stesso nel 1957.
Sulla scia di quel libro, oggi sempre più cult, in un contesto dove si stanno perdendo i riferimenti di cosa sia obiettivamente giusto e cosa obiettivamente sbagliato, Valerio Varesi ha scritto una storia che avvince da subito il lettore per la rottura degli schemi noir cui siamo abituati: Soneri ha già in mano, nelle primissime pagine, il colpevole, omicida reo confesso; e, subito nelle successive, riceve da lui stesso la rivelazione anche del luogo in cui si trova la vittima, le modalità dell’assassinio, l’arma del delitto. Eppure non può capacitarsi che tutto si riduca lì. Abituato alla nebbia padana, che attenua le luci e soffonde i confini, Soneri si sente stordito dall’eccessiva limpidezza del caso, dal rovesciamento dei ruoli: “Dovrei essere io a cercare i fatti, districandoli dall’oscurità di chi vuole tenerli nascosti. Non capita mai che qualcuno te li racconti già bell’e messi in fila come i paracarri”. E diffida. E’ vero che non è la prima volta che si trova di fronte ad un reo confesso ma questo è decisamente diverso: troppo sereno, troppo obiettivo, troppo esaustivo nei dettagli. Qualcosa tra loro si è innescato fin dal momento in cui il caso li ha messi l’uno di fronte all’altro, quel giorno, in quel parco, su quella panchina dove il commissario lo ha sorpreso intirizzito e quasi svenuto. Lo ha scosso preoccupato e l’uomo ha sentito in quel gesto, nello sguardo e nelle parole che gli ha rivolto, tutta la sensibilità e la differenza di chi gli stava di fronte. Non uno qualunque, non un semplice poliziotto. Agli arresti domiciliari, Ferrari, non può muoversi, e chiede ripetutamente che il commissario lo vada a trovare avviando con lui un dialogo che sembra disperatamente rivolto a spiegargli qualcosa che va oltre il suo delitto: “Volevo solo che volgesse lo sguardo anche verso quel magma ribollente che porta a questi esiti. Se lo osservassimo attentamente, ci accorgeremmo che siamo un po’ tutti, chi più, chi meno, degli assassini. E contemporaneamente delle vittime. È questo miscuglio imperscrutabile di bene e di male a confonderci. E per questo la legge ha bisogno di distinguere. Ma la sua rigidezza formale non si adatta alla molteplicità dell’umano. I fatti sono pieni di diavoli e angeli che se le danno di santa ragione”.
Soneri vuole indubbiamente capire, ma è profondamente diviso: da un lato il senso del proprio ruolo professionale che lo porta a mantenere la dignità del caso risolto con tutte le prove e gli indizi che convergono sul reo confesso; dall’altro il suo istinto umano, che gli fa percepire, dietro l’apparente limpidità della confessione, forme in dissolvenza, ombre di qualcos’altro che non si è palesato. E in questa veste, Soneri riflette nettamente Matthäi, il commissario protagonista del romanzo di Dürrenmatt, il quale, alla madre della ragazzina violentata e uccisa, ha fatto la solenne promessa di trovare il colpevole; quella promessa che, con l’arresto di von Gunten sulla base di indizi in prima approssimazione incontrovertibili, sente di non aver adempiuto. Soneri è come lui. E’ insoddisfatto. Aleggia dentro il suo animo un insostenibile senso di incompiutezza, anzi, di inganno.
La nebbia che offusca quella vicenda troppo plateale per essere credibile, il senso di imbarazzo nel quale i ripetuti fallimenti nel caso delle truffe lo mantengono, tolgono a Soneri la capacità di distinguere i confini delle persone, dei loro atteggiamenti, della loro sincerità. Sono i suoi più fidi collaboratori, Juvara, Musumeci, Nanetti della scientifica, a tenerlo saldo; e Sbarazza, il nobile decaduto, entrato con successo nel cast di Oro, incenso e polvere (ottavo romanzo della serie), il platonico don giovanni, la cui personalità è un sorriso alla vita per come si presenta giorno per giorno, per il solo fatto che gli schiude con una nuova alba. Sbarazza è per Soneri una prospettiva diversa e consolante che gli permette di guardare la realtà non solo in quella prospettiva sghemba dalla quale spesso guardava le cose e le persone per farsi sorprendere. E’ l’amico che gli mostra che la realtà immaginata o falsata può vantare a volte la stessa dignità di quella reale e terrena spesso carica di brutture. Ed emblema di coloro che di quelle brutture sono vittime completamente innocenti, è l’umile, infelice segretaria che Soneri segue nei viaggi notturni in bus alla vana ricerca di ricordi perduti, Veronica Mariani, nella quale “erano concentrati l’amarezza e il fallimento di una donna che era invecchiata nella speranza di essere vera: una vera amante, una vera madre e una vera professionista in quello studio dove passava la città dei ricchi. Invece era rimasta ferma a metà strada nella metamorfosi che avrebbe desiderato compiere: non era più bruco, ma nemmeno aveva mai volato da farfalla”.
Varesi ha indagato, come Dürrenmatt, il caso della vita, una realtà più strana e insospettabile, più ingestibile di quella che vediamo, vogliamo vedere o semplicemente ci accontentiamo di vedere ogni giorno. Una realtà sottile, dove il male gioca con regole diverse da quelle che ci aspetteremmo, dove la giustizia non ha la G maiuscola, perchè ha mille sfaccettature, come il prisma al quale, in quella bellissima immagine, quasi un verso poetico che fa pronunciare a Sbarazza, Varesi paragona l’umanità stessa: “Siamo prismi di cristallo che il tempo ruota. Riflettiamo di continuo un’immagine diversa”. È questa “contraddittorietà dell’animo umano” il centro della trama del romanzo, la mobilità delle posizioni, dei moventi, delle complicate manifestazioni emozionali, “un vero ring dove combattevano l’amore e l’odio, la sincerità e il sotterfugio, il benefattore e l’assassino”. E Soneri, abituato alle “strane danze della nebbia, figure che comparivano e si dissolvevano come pensieri notturni”, abituato a camminare “dentro quella pantomima di spettri”, è la persona adatta a cogliere la caducità dei verdetti o, addirittura, la loro inemanabilità per quei reati non perseguiti a norma di legge, “quelli per cui non c’è un articolo, un comma o un paragrafo che possa esprimere una condanna (…). Non c’è nessuna legge che tuteli dai soprusi, dalle prepotenze, dall’approfittare del prossimo. Si può essere delinquenti senza aver mai commesso un reato”. È questa realtà che ha voluto rappresentare Varesi: la realtà nella quale l’innocenza non riesce a venir fuori perchè veste i panni della colpevolezza, che rimane per dolo o destino invisibile e sfuggente. Una realtà che è grigia e soffusa come la nebbia, più umida e meno accogliente del palcoscenico illuminato tipico dei finali classici, nei quali buoni e cattivi ufficiali giocano il proprio ruolo indiscusso. Ma Soneri ama la nebbia e la conosce, non la fugge, ci si immerge, aspettando che siano le cose a profilarsi al momento giusto: “meglio non capire, così si continua a cercare. Che poi è l’unica salvezza”.