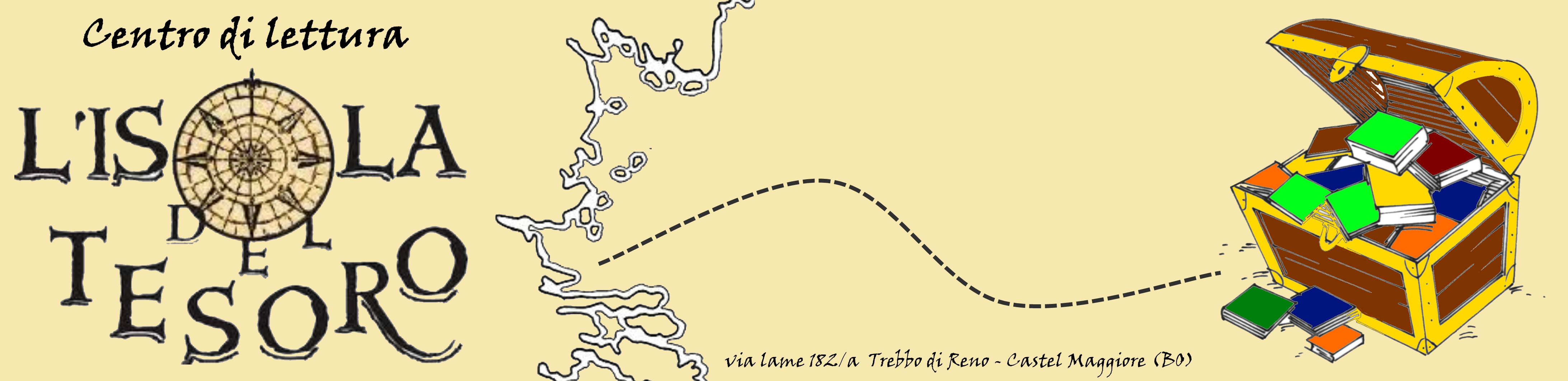C’era una volta o forse non c’era, di Benedek Elek, a cura di Elisa Zanchetta (Vocifuoriscena)
Elisa Zanchetta, esperta in letteratura ugrofinnica, padroneggia il tedesco, l’ungherese, il finlandese, il norvegese, lo svedese ed il georgiano. La sua passione per la narrativa di genere mitologico, leggendario, fiabesco, cosmologico, l’ha portata a scoprire il tesoro delle fiabe ungheresi che Benedek Elek, scrittore, saggista, giornalista vissuto nel XIX secolo, aveva raccolto e pubblicato nel 1896 in occasione del Millennium, i mille anni della presenza degli ungheresi nel bacino dei Carpazi, in un corpus in cinque volumi dalla voce della tradizione popolare e orale, spigolando contenuti mitologici che fino ad allora si ritenevano inesistenti. Errore: anche l’Ungheria ha una sua epopea mitologica frammentata nel mare di fiabe e leggende popolari.
In questo libro, Elisa Zanchetta, selezionando quelle che presentassero i più importanti temi della favolistica ungherese, ne ha raccolte e tradotte quattordici. Alcune di queste richiamano già nei titoli quelle di Calvino che ha operato in modo simile a Elek, raccogliendo dalla voce popolare di ciascuna regione un immenso e affascinante patrimonio di fiabe.
Ma la fiaba ungherese oltre alle caratteristiche proprie di ogni fiaba – racconto profano che nasce “quando un popolo abbandona la propria religione e adotta un nuovo credo, svuotando l’antico corpus di credenze del suo contenuto sacrale e lasciandolo sopravvivere sottoforma di mito privo di valore dottrinale” – possiede numerosi tratti in comune con la tradizione altaica e siberiana, sia nella formularità, sia nei motivi di origine sciamanica.
Il formulario, infatti, oltre ai topoi anche nostrani, come la reiterazione del verbo camminare per dare l’idea di un lungo percorso spirituale oltre che materiale (“cammina, cammina” diciamo noi, “camminò, camminò e camminò” si trova nelle fiabe di Elek), presenta espressioni originali e molto suggestive come la frase di autoincoraggiamento che l’eroe pronuncia quando deve affrontare un grande cambiamento e accettarne il rischio: “la vita e la morte sono una, buona fortuna!”, o ancora, “il pover’uomo aveva tanti figli quanti i fori di un setaccio, perfino uno in più”; e, infine, proprio la frequente formula di chiusura, così insolita per la nostra tradizione, nella quale il narratore si rivolge direttamente all’ascoltatore: “Vivono ancora oggi se non sono morti. Speriamo che domani siano vostri ospiti!”, esprimendo l’augurio che portino, visitando chi ascolta (o legge), la stessa loro gioia nella sua casa.
Topoi peculiari della favolistica ungherese sono poi alcuni esseri sovrannaturali che a volte hanno la loro corrispondenza nella nostra tradizione, come la boszorkány (strega), o il sárkány (drago, pur con caratteristiche particolari come il fatto di possedere sette teste e di avere comportamenti prettamente umani: parla, si nutre, rapisce fanciulle). Altre volte, invece, le figure magiche sono totalmente originali, come la tünder che solo in prima approssimazione ricorda la nostra fata, ma che in realtà è ben più profonda come personalità, più concreta, più umana, più femminile, nelle sue reazioni emotive. O come, soprattutto, il táltos, figura totalmente nuova, che qualifica come essere soprannaturale intermediario fra il mondo inferiore, medio e superiore, intrepido combattente, dotato di poteri predittivi e magici, non solo uomini e donne ma anche animali. Animali che abbondano quasi esclusivamente nel ruolo di aiutante dell’eroe, saggio consigliere o protettore. Così, il cavallo – peraltro tipica cavalcatura sciamanica -, la capra, la mucca, il maialino, gli uccelli, si trovano a fornire al protagonista le informazioni fondamentali per poter superare gli ostacoli e vincere il nemico.
Oltre al tema della formazione etica dell’eroe attraverso una partenza, dell’abbandono della casa natìa – che qui ha spesso il contraltare del ritorno –, tipica della favolistica in genere, troviamo il tema del rispetto dei patti, della fiducia nell’amato che richiama la prova di Amore e Psiche (La fata Erzsébet), il tema del non guardare in risposta allo sguardo insistente dell’altro, come prova di autocoscienza, di capacità di discernere il bene dal male e ancora il tema del rispetto e del riconoscimento dell’anziano, che l’eroe saggio manifesta rivolgendosi a loro con nonnina se è una donna o zio se è un uomo.
Infine, le fiabe traboccano di una fervida simbologia, che si aggancia al quotidiano, come le noci che custodiscono cose preziose, il ferro che ricopre uno o più arti di una persona, dissimulando così la sua appartenenza alla sfera del sovrannaturale, a volte demoniaco (La donna col naso di ferro, che richiama la fiaba calviniana Naso d’Argento). Questo simbolo si rifà alle pratiche pagane propiziatorie che costruivano degli idoli con ceppi di legno ricoperti di maglie metalliche per preservarli dalla decomposizione e che, per contraddistinguerne l’antropomorfismo, venivano decorati con un chiodo come naso.
Il libro si presenta corredato di un utile glossario finale che approfondisce i termini più particolari della cultura ungherese, di un capitolo dedicato alla figura dell’autore, Benedek Elek, che tanto fece per il popolo ungherese, in particolare per quello dei ragazzi: fu tra i primi e pubblicare rubriche di corrispondenza con loro, a produrre dei sussidiari di storia e altri libri di testo.