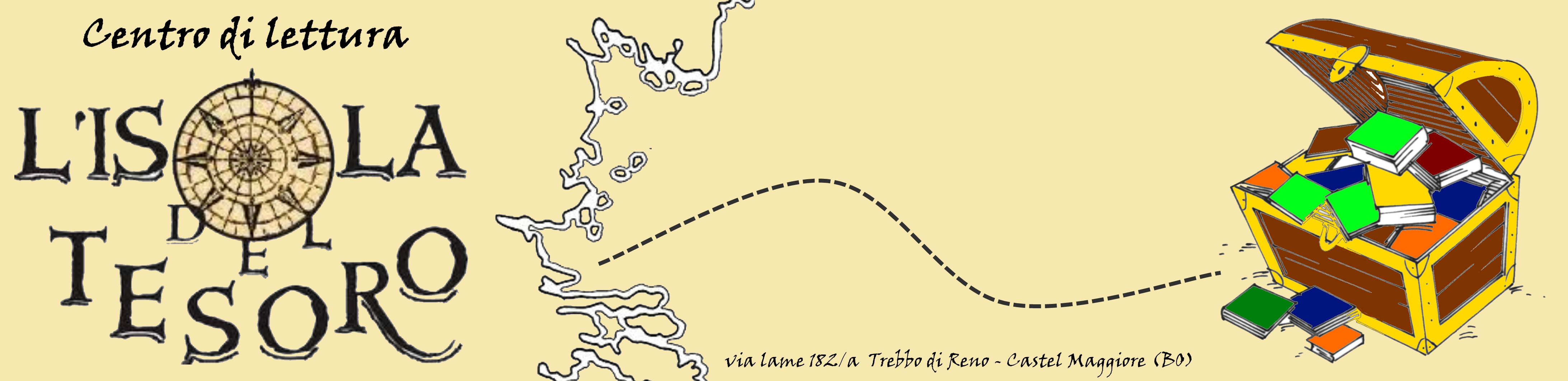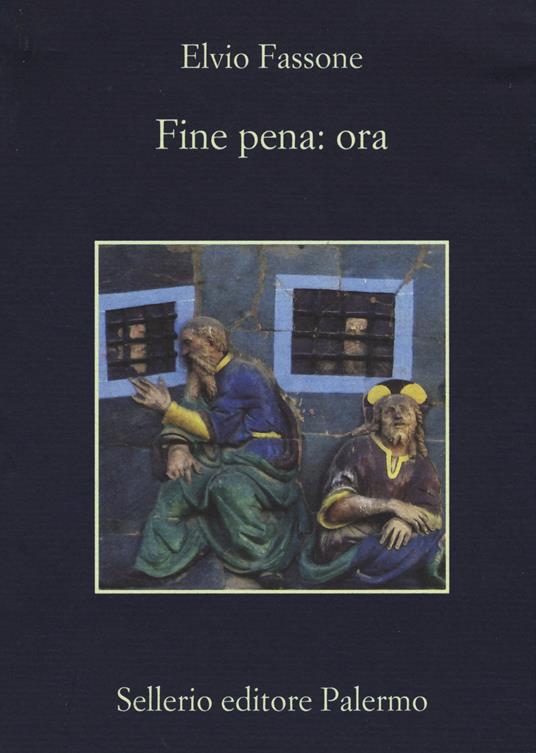
Fine pena ora, di Elvio Fassone (Sellerio)
Non è un romanzo, ma una storia vera.
Ex magistrato e membro del Csm, Fassone narra la corrispondenza lunga 26 anni – “la terza parte di un’esistenza media. Sono la gioventù e l’età adulta assommate – che ha intrattenuto con un ergastolano da lui condannato.
Salvatore, Gatto selvatico nel suo ambiente, è uno dei 242 imputati del maxi processo alla mafia catanese iniziato nel 1985 a Torino. Fassone è il presidente della Corte d’Assisi che li giudicherà. Il clima è quello della guerra, di cui il venticinquenne Salvatore è un capo, un eroe, determinato a battersi fino all’ultimo sangue. Lo dimostra davanti al giudice istruttore, quando si ferisce con una lametta nascosta sotto la lingua spargendo sangue sulla scrivania, sui fogli e forse anche addosso al magistrato.
Il primo contatto personale avviene con la richiesta del detenuto di visitare la madre malata libero dalle manette. Fassone acconsente a farlo scortare da agenti in borghese e alla domanda ‘Posso fidarmi?’ riceve la risposta ‘Si può fidare’. Ad alimentare questo embrione di rapporto contribuisce il colloquio a fine processo in cui Salvatore chiede al presidente se ha un figlio – ‘Glielo chiedo perché le volevo dire che se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo’ – e lo porta a riflettere sulla lotteria della vita.
Ricordando quelle parole, a fine processo il giudice decide di scrivere all’uomo divenuto ergastolano in virtù di quel fine pena mai che ha sancito la condanna definitiva. Con l’intento di esortare il condannato a sperare di ‘poter essere madre della sua seconda nascita’, sceglie fra i suoi libri il volume che accompagnerà questa prima lettera. E’ Siddartha, in cui nelle ultime pagine Hesse scrive: ‘Mai un uomo, o un atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un uomo è interamente sano o interamente peccatore.’ Il Gatto Selvatico gli risponde con parole inaspettate, sgrammaticate e profonde, perdonandolo per la condanna inflittagli e assicurandogli che seguirà i suoi consigli.
A questo primo scambio seguiranno 26 anni di corrispondenza, un lungo tempo in cui Salvatore vive la detenzione passando attraverso fasi diverse – di rabbia, di lotta, di sconforto, di speranza, di disperazione, di fiducia – aiutato dal rapporto con il giudice e confidando in un futuro, se pure lontano: “il passato lo voglio dimenticare, voglio solo ricordarmi del presente, che sicuramente sarà più bello della vita che ho fatto, e poi si può vivere una vita serena anche in carcere, con la speranza che un giorno posso uscire di libertà”.
Anche la vita di Fassone cambia, entra nel Csm, va in pensione, e sempre continua a riflettere sulla detenzione, morte parziale dell’individuo, che può diventare persecuzione quando non sia mitigata da un trattamento educativo, come le vicende del detenuto dimostrano.
Non scrivo di più per non spoilerare. Il libro, che non è un romanzo e non è un saggio, tocca corde profonde, della ragione e del cuore, fino alle ultime righe, una citazione di Silvia Giacomoni: “il carcere è per castigare certi gesti, ma poi punisce anche parti che la persona forse non sapeva di avere, parti innocenti che magari si scoprono solo quando vengono ammutolite a forza, e recise. Il carcere è per gesti che non andavano compiuti: ma la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia”.