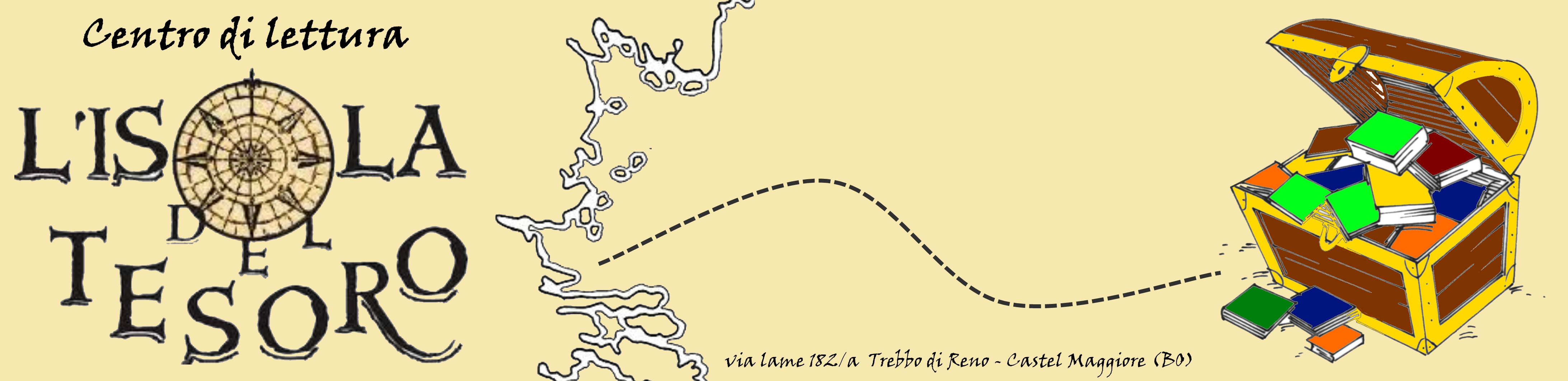Il lungo inverno, di Maurizio Garuti (Minerva)
Più cronache di vita partigiana che romanzo, ma non solo cronache perchè le storie vere scovate da Garuti in “tomi preziosi ma quasi intonsi che giacciono sugli scaffali di biblioteche frequentati solo da pochi studiosi” (Anna Cocchi nella Prefazione) diventano nelle sue mani racconti profondi e toccanti. Garuti è un maestro di storie. Le sa inventare. Con fantasia e originalità. Ma sa anche raccontare la realtà e farne un romanzo senza che il tocco dello scrittore tolga nulla all’autenticità degli eventi. E’ per questo che è stato affidato a lui il compito di raccontare le vite di Marcello Zanetti, Emo Tartarini, Adelio Stanghellini e dei partigiani della brigata “Paolo” di San Pietro in Casale e delle piccolissime località che lo componevano: Ponticelli, Tombe, Maccaretolo, Mascarino, Argelato, Funo e tante altre.
In capitoli brevi, uniti dal fil rouge di Marcello Zanetti, comunque protagonista diretto o indiretto dal primo all’ultimo, compaiono sul palcoscenico del racconto in unica uscita o in più momenti, altri personaggi drammatici: la piccola Marisa che riesce a depistare il tedesco e ad ottenere lo stesso il suo pezzo di cioccolato, Adriano Benfenati che finì per fasi cavare davvero un dente per essere stato sorpreso da una ronda tedesca ad attaccare manifesti clandestini, la giovane e bella staffetta Albertina Girotti, uccisa a Sant’Agostino, Elio Cicchetti, detto Fantomas che a Baricella brucia una delle trebbiatrici che i Tedeschi minacciavano di usare per togliere loro il grano; e tanti altri, splendide icone di abnegazione e sacrificio. Non per qualcosa di lontano, astratto e non veramente compreso: per se stessi, per i propri familiari, i propri vicini, i propri animali, per le proprie cose, i propri campi. Per quella che era la loro vita di persone. Di individui con un proprio nome, con dei legami di sangue, di affetto, di territorio. Quel territorio che è terra e case. Per quella terra, quelle case, quelle persone che conoscono una per una, i partigiani combattono.
E’ il lungo inverno del ’44, un inverno di terrore, di lutti: bombardamenti, denunce, violenze, ritorsioni, vendette che chiamavano vendette in un loop straziante. E spesso, più della rabbia, emerge la profonda stanchezza, la reazione dovuta più che voluta, l’atto compiuto per ineluttabilità più che per eroismo. Per cercare, disperatamente, di difendere il proprio mondo che da quell’assurda sanguinosa guerra civile che si era incuneata nella già tremenda guerra internazionale. L’armistizio era stato un cataclisma sociale: dalla prospettiva di gettare la divisa nella certezza – o speranza – che finalmente sarebbe arrivata la pace, alla più grande delle delusioni, il richiamo alle armi: “La guerra continuava e reclamava quei giovani, li voleva di nuovo in uniforme, e in armi. Quei giovani si cercarono. Si cercarono fra loro. Si strinsero smarriti (…). Una generazione finita fra le ruote dentate della guerra. Tu che fai? Noi che facciamo? Alcuni scelsero di ribellarsi affrontando la prospettiva della clandestinità, che era ancora una cosa vaga, tutta da costruire e organizzare. Altri si nascoser, imbucandosi sotto terra come animali in letargo, aspettando che passasse la tempesta. Altri piegarono il campo con rassegnazione davanti a quella che si presentava come l’unica residua autorità pubblica, in grado di minacciare pene di morte ai sudditi ribelli. Qualcuno invece aderì con convinzione in nome dell’onore, per coerenza con le decisioni che uno solo aveva preso per tutti”.
Garuti approfondisce il sentimento di questa stanchezza che si riverbera in una paura diversa, non solo e non tanto quella dei bombardamenti, dove “a decidere l’esito era di solito la fortuna o la sfortuna”, ma piuttosto e soprattutto quella “dell’automobile che si fermava sotto le finestre, le portirere che s’aprivano, i passi spediti che siavvicinavano alla tua porta, alla tua scala”. Quella, come descrive mirabilmente nel racconto 30, era la paura che toglieva il respiro e quella era la guerra più temibile, perché arrivava in casa, contro il singolo, l’individuo con un nome preciso, non un soldato di un battaglione. Era la paura della guerra che entrava nelle famiglie per strappare legami di una vita. È in questa delicata analisi che l’autore restituisce tutta la soggettività delle testimonianze, i nomi, le storie, i rapporti reciproci fra singoli.
Prede e predatori, ribelli e invasori, italiani e italiani, italiani e tedeschi, italiani e alleati giocano una partita in doppio con la vita e la morte, rimbalzandosi con rabbia e stanchezza, la pallina della colpa. Un gioco che non si riesce più a seguire, dove si sa solo che non ci sarà di certo un vincitore ma due vinti. Oppure, al contrario, ma molto di rado, due vincitori, come nel bellissimo capitolo 26, nel quale dopo una giornata passata a districare i panzer da un campo di canapa che si attorcigliava ai cingoli, ed aver perduto un soldato sull’esplosione di una mina mentre cercava di aprire un varco alla colonna, il tenente Franz L. sembra quasi sollevato dall’impossibilità di raggiungere, secondo gli ordini ricevuti, la zona dove avrebbero dovuto fare un rastrellamento. E quando, finalmente di nuovo in marcia lenta riprendono la strada, incrociano una colonna di partigiani: “Poteva essere il momento di una sparatoria allo scoperto, un reciproco tiro al bersaglio, uno contro l’altro, fno all’ultimo uomo”. Invece, il tenente Franz L. “fece cenno ai suoi soldati di non muoversi”. È una testimonianza di Enzo Biondi, partigiano del battaglione Campelli, riportata quasi con incredulità. E rende atto di una stanchezza diffusa davvero su tutti i fronti.
Sempre splendida, inimitabile la scrittura di Maurizio Garuti: titillante in frasi brevi, a volte brevissime, come piccoli passi compiuti con attenzione e circospezione; scorrevole com il fiume al quale ha dedicato altrove pagine bellissime; pertinace e fedele nella ricostruzione; delicata come un merletto per il rispetto della semplicità della gente protagonista.