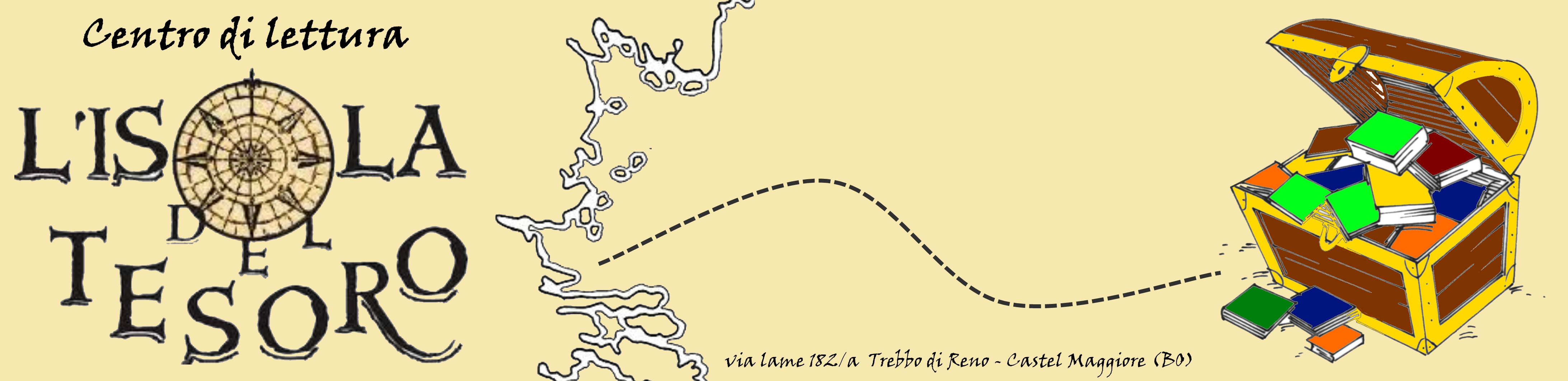Il paese di Saimir, di Valerio Varesi (Centoautori)
Spietato e disperato. Senza la pietà di chi fa solo il proprio interesse, senza la speranza, per tanti, di poter cambiare e rasserenare il proprio futuro. Un romanzo sulla realtà corrotta e senza scrupoli del mondo dell’edilizia più bieca, quella dello sfruttamento del lavoro nero, degli appalti strappati per vie traverse, dell’impiego di materiali scadenti alla ricerca dell’accumulo senza freni e inibizioni. Di questo gioco brutale, nelle mani del ricco e impastato imprenditore Rivalta, ne paga il prezzo più alto, quello della vita, Saimir, diciottenne albanese che insieme ad altri tre conterranei di poco più grandi, di poco più scaltri, viene ogni giorno prelevato dal capomastro Inardo, uomo gretto per non aver voluto più che potuto, riconoscere nella vita l’esistenza di un’etica al di là della mera necessità – e portato sul cantiere, per un lavoro di massima precarietà, un bracciantato malpagato, totalmente privo di dispositivi di sicurezza. Ma l’unica possibilità di restare, se pur di nascosto e illegalmente, in un paese che forse poteva offrire qualcosa di più di quello dal quale lui, come gli altri, erano fuggiti.
Varesi compara due paesi per un aspetto totalmente diversi, quello del benessere e delle opportunità, per un altro del tutto simili, quello delle prevaricazione e dello sfruttamento. Dagli occhi di Vera, la madre di Saimir che cerca il figlio nei programmi televisivi, come se la tv fosse una finestra, dai suoi ricordi, dai suoi pianti, emerge una famiglia come tante disfatta dalla miseria e dall’ignoranza, nella quale, una volta che i figli se ne sono andati alla ricerca di una vita migliore, non resta più nulla: “erano loro gli interpreti in grado di mettere in contatto i mondi separati dei genitori”. Emerge un’Albania disperata, dove sembra che l’uomo abbia mantenuto condizioni di esistenza, cultura, socialità primitive, nelle quali non c’è spazio per la collaborazione, la costruzione solidale, ideali condivisi. Ci sono sfruttamenti, violenze, faide familiari che schiacciano i più deboli, donne e bambini.
Saimir passa due giorni d’inferno, imprigionato sotto le macerie, oscillando da una rabbia sorda per chi non fa nulla per aiutarlo ad una disperata speranza che invece gli amici lo stiano cercando; dall’odio al perdono, icona del martire innocente, la cui colpa è l’inconsapevolezza, la giovane età, l’essere straniero; l’essersi trovato, ingenuamente, nella condizione di aver davvero bisogno degli altri, di non potere, per una volta, fare da solo. Ma gli altri, più veloci nell’uscire dal palazzo prima del crollo, resisi conto dell’assenza del ragazzo, erano sì andati subito a cercarlo, ma sapevano bene che da soli non sarebbero mai riusciti a ritrovarlo. E non avrebbero potuto chiamare soccorsi in quanto avrebbe significato rivelare la loro condizione illegale, perdere il lavoro e soprattutto, privi del permesso di soggiorno, essere rispediti in Albania: “Erano un niente, non avevano nemmeno l’effimera esistenza conferita da un’identità riconosciuta”.
Sono diversi fra loro, Mentor, il più maturo, trentenne, Altin, il più sfrontato e disinibito, Sabri, il più giovane dopo Saimir, più ingenuo, più fragile. Nonostante abbiano tutti un’aspirazione diversa, sono, nel sistema economico-sociale nel quale hanno cercato un riscatto, in fondo tutti uguali: “Contava solo la vita e per questo bisognava viverla bene. Spenderla e basta, sapendo che più di tanto non puoi decidere. Non dove nascere, non la condizione, non quello che sarai”. Emblematica la prima notte che passa dopo l’incidente, una notte di ricerca, di pensieri contrastanti, di rimorsi repressi, di alternative possibili.
Un romanzo che, come il palazzo fatiscente che aveva schiacciato Saimir, schiaccia tutto un sistema economico-sociale: quello albanese, da cui si vuole fuggire, quello italiano, per certi versi, non meno subdolo e malevolo. Un miscuglio di svilimento e mancanza di valori che si delinea, sconfortante, in quella immagine della madre di Saimir che da lontano, maledice quel miraggio di speranza che aveva tradito suo figlio, “inghiottito da quella vita fatta di immagini e parole che sempre scorre e macina tutto. Quella che ci porta via gli affetti, indifferente ai nostri dolori, che ci consegna disgrazie e raramente qualcosa di buono. Quella che non possiamo fermare. Come quel continuo fluire di chiacchiere sullo schermo che passa senza soluzione di continuità dall’allegria alla tirstezza, dalla morte alla vita, dalla ricchezza alla povertà, in una miscela che rimbomba (…). Il mondo dorato che si vedeva in televisione era un’immensa bugia”.