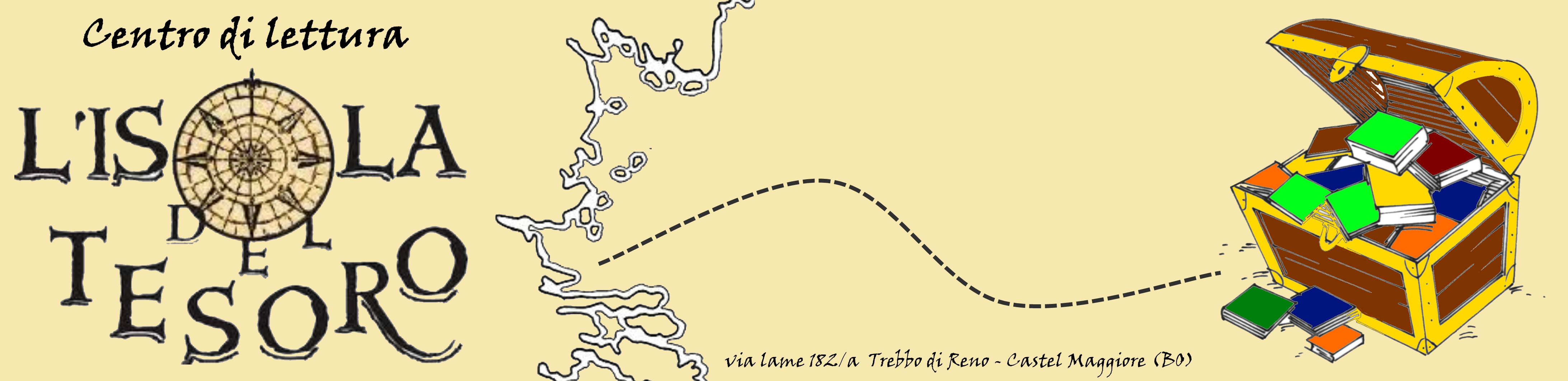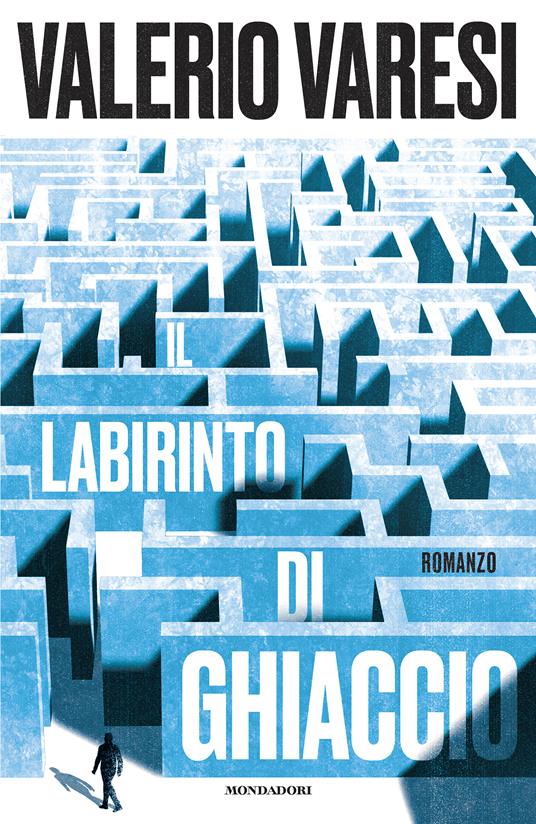
Il labirinto di ghiaccio, di Valerio Varesi (Mondadori)
Dopo L’ora buca, Varesi affronta ancora il tema del rapporto fra l’individuo e la realtà contestuale. E lo fa con una storia bellissima, originale, suggestiva che vede il protagonista, io narrante, volutamente senza un nome, raggiungere un picco sulle Alpi (anche il luogo è volutamente non definito), con uno scopo ben preciso che si coglierà nel corso del romanzo. Se nelle prime pagine, si coglie come tema principale la ricerca di evasione, di solitudine, di non omologazione, a poco a poco si comprende che l’autore non ha voluto fermarsi a quello, ma lo ha ampliato e articolato in temi corollari: la volontà di distinguersi, il bisogno di emergere, di agire sul consesso civile come un regista e non come mero personaggio.
Così, la prima sfida da superare è certamente quella della natura nelle sue condizioni più estreme e primitive, per dare prova della propria capacità di resistere dove nessun altro potrebbe farlo: “Ho voglia di lottare e conquistare palmo a palmo questa roccia fino a farne un mondo esclusivo in cui riconoscemi. Forse solo allora, ricondotto alla spontaneità di un bimbo che impara, mi spoglierò di tutto e i calerò come uno speleologo dentro me stesso”. Ma poi, diventa una sfida verso gli altri: prendersi gioco di loro, divertirsi ad osservarli di nascosto, intervenire nelle loro vite, condizionare i loro pensieri: “Questo angolo di monti è il mio laboratorio (…) Condiziono la vita dei paesani, la manovro, ne oriento gli umori e ne scandisco il tempo. Tutti sono condizionati dal mio agire senza volto. Muovo da lontano provocando carambole di fatti. Misteriosamente, li sconcerto standomene quassù dietro le nubi. Come un dio”.
Minuscoli frammenti della sua vita passata sono sparsi nelle pagine: il lettore più curioso può impuntarsi di raccoglierli e ricomporre per dare un’immagine precisa al puzzle sparpagliato di ricordi allo scopo di scoprire che cosa lo ha portato ad una svolta così radicale; un’altra tipologia di lettore può scegliere, invece, di lasciare dove sono, accontentandosi di sapere che ci sono delitti nascosti e mai scoperti, rancori lontani, colpe imperdonate, vendette insoddisfatte.
Il labirinto è un simbolo potentissimo proprio perchè si adatta a diverse dimensioni: è il labirinto scavato per mesi all’interno del ghiacciaio, che è nello stesso tempo rifugio per sè e trappola per gli altri. E’ il labirinto della propria mente (“eseguendo questi lavori ho scoperto un dppio fondo nella mia mente nel quale abita un altro me stesso con cui fare i conti e che spesso l’ha vinta”); è il contorto percorso che si rende conto di avere davanti a sè per poter trovare il filo del proprio rapporto con gli altri; un filo che s’ingarbuglia e lo ingarbuglia con la curiosità, l’invidia, la debolezza. E’ anche, sorprendentemente, il labirinto di un gioco virtuale che rappresenta uno dei colpi di scena della storia.
E, altrettanto fondamentale potentemente simbolico è il complemento di materia del labirinto, “di ghiaccio”, che esprime letteralmente e metaforicamente, la freddezza, la bellezza fulgida, la potenza e fragilità insieme.
C’è un unico affetto che, nel protagonista, in questa esistenza di strappi, rimane saldo, un’unica verità che sovrasta il deserto di illusioni o, peggio, di menzogne che compongono la storia quotidiana della nostra società. Un affetto che affonda le radici nel fertile terreno dell’infanzia ma che resta sfuggente e incerto. Forse perduto.
In questo romanzo, la prosa di Varesi è al massimo della sua espressività: una delle sue caratteristiche più pregiate è l’uso modernamente poetico delle metafore, delle analogie, delle similitudini. Riesce a combinare le parole di campi semantici diversi in un’armonia dalle molteplici sonorità: la minaccia che sente incombere è come “il ciclico, fastidioso stridore di un perno asciutto”; spezzoni di ricordi riaffiorano nitidi ma distaccati, “palesandosi su un’unica superficie senza più profondità di tempo, come in un disegno egizio”; non solo il tempo, ma soprattutto una vita di stenti e fatica costruisce “giorno per giorno una maschera sui nostri volti. Le smorvie che induce piegano progressivamente la pelle del viso come se l’intagliassero col coltello. E tutt’intorno disegna rigagnoli attraverso i quali se ne va la giovinezza”; e dal crollo delle illusioni nelle quali aveva vissuto, in uno sdoppiamento di se stesso tra carnefice e vittima, sente che ;nel profondo di sé “alligna una risata che non ha il coraggio di manifestarsi. Ed io non voglio farle da levatrice”, il compianto per gli ignavi, per coloro che non hanno, come lui, conosciuto le prove estreme, “quella dogana che tutto requisisice e ci lascia solo l’essenziale” e, infine, l’inganno della comunicazione che, “in questo mondo impalpabile, è un volo di pernice: una partenza di scatto seguita da un arresto altrettanto rapido”.